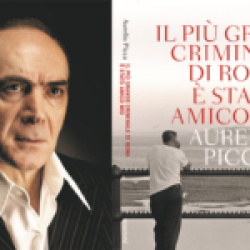Abbiamo conosciuto la vena sarcastica e azzerante di Ottessa Moshfegh ne Il mio anno di riposo e oblio (Feltrinelli): nella New York del Duemila, una ragazza snob dell’Upper East Side per superare un momento duro sceglie di passare un anno intero addormentata, facendo provvista di narcotici da una psichiatra incapace, dimentica ogni volta dei traumi della paziente (la morte dei genitori, what else?). Data del risveglio: l’11 settembre.
Essere e sentirsi fuori posto, o porsi fuori da soli, spesso sgradevolmente ripiegati nella miseria della propria corporeità (vedi pure i racconti di Nostalgia di un altro mondo, Feltrinelli) è un tema peculiare della scrittrice di padre iraniano e madre croata, nata a Boston, cresciuta a Newton, poi di stanza a New York, salvo una parentesi di tre anni a Wuhan (!) – docente di lingue e al banco di un bar aperto col fidanzato di allora.
La morte in mano – romanzo nuovo ma scritto prima de Il mio anno – certifica: è “Moshfegh allo stato puro”, incardinato sulla solitudine e sul vuoto sopra cui nasce e finisce il racconto, come la vita si chiude con la morte. Nel mezzo, una protagonista in bilico sugli eventi, sospesa tra attrazione per il mistero umano e una difensiva e quasi ottusa perplessità.
Nel bosco vicino a Levant, luogo in cui nessuno è inquieto – così veniamo avvertiti – una signora passeggia col cane. È Vesta Gul, settantenne di origini europee, da poco vedova dell’epistemologo Victor e appena trasferitasi in un isolato chalet sul lago, è lei che si trova per caso tra le mani un macabro biglietto. Il cartiglio annuncia la morte di Magda – sconosciuta, di cui peraltro non è in vista il cadavere – e la non colpevolezza dell’anonimo scrivente.
Un “giallo senza cadavere” è già un indizio che l’indagine di Vesta si svolgerà all’insegna della reticenza. Anzi: la signora si inventerà da sola red herrings e false piste civettando con la Christie – benché le muse di Moshfegh siano Du Maurier e Highsmith – prima di sprofondare più che precipitare, pagina dopo pagina, negli enigmi di un incubo, popolato di personaggi antipatici o pericolosi, cui all’apparenza Vesta stessa conferisce nome e funzione; ognuno di essi è portatore di spiacevoli verità, anche se forse la più spiacevole se la porta addosso, da prima e come tutti noi, proprio la protagonista. È spoilerare dire che siamo destinati a morire?
Moshfegh si comporta come dice a pag. 69, essendo “…il compito dello scrittore sminuire i miracoli di questa Terra, individuare una domanda nell’infinito mistero della vita, e dare una risposta patetica”. Oppure, ancora più ambiziosa, ci impartisce una “lezione americana” – un panorama dell’America – nutrita da languori pop e suggestioni dark tra Henry James e David Lynch, portandoci e lasciandoci, quasi a tradimento, in una disperata landa di nessuno. Dove al the end rimane in piedi – cioè viva – unicamente l’abilità della scrittrice. Bella la traduzione di Gioia Guerzoni. Buona lettura.

IL LIBRO Ottessa Moshfegh, La morte in mano (Feltrinelli)