Sfondo una porta aperta dicendo che uno dei temi di László Krasznahorkai (Gyula, Ungheria, 1954) è l’aspettare dei pezzenti, l’estrema speranza che agita i miserabili. Si ritrovano in complottante attesa attorno allo Stabilimento abbandonato di Satantango (1985), presidiano il carrozzone misterioso di Melancolia della resistenza (1989), affollano la stazione della cittadina angusta che pare ritrovare un soffio di vita all’arrivo di un aristocratico demente ne Il ritorno del barone Wenckheim (2016, tutti editi Bompiani).
Nessuna di queste attese messianiche può pareggiare le aspettative: lo si ricava dal clima di degrado irreversibile nel quale veniamo da subito precipitati e dal fatto che ciò che si attende non è chiaro neppure ai personaggi stessi. Krasznahorkai mescola angosce metafisiche, costruite con incredibile bravura in lunghi pianosequenza, a deliranti sogni da straccioni che, se devono qualcosa a Beckett, lo declinano però al quadrato: gli straccioni, si evince in Satantango, sono a loro volta attesi, Vladimir e Estragon si elevano cioè alla stregua di implausibili Godot.
Il ritorno del Barone Wenckheim, diversamente dai due precedenti romanzi citati che facevano i conti con comunismo e post comunismo, va per tempi contemporanei, nell’Ungheria fascista, e aggiunge alla trimurti letteraria spesso evocata (Gogol-Kafka-Beckett), un quarto nume tutelare, essendo chiaramente Wenckheim un parente prossimo del principe Myshkin: l’innocente sarà nondimeno coinvolto in infernali sprofondi, questi ultimi destinati a fargli raggiungere vette quasi karamazoviane.

Non stupiscano gli echi tra un titolo e l’altro: Il ritorno del Barone Wenckheim, ha spiegato nel 2018 Krasznahorkai a The Paris Review, è il quarto in una serie che gli ha permesso di raggiungere ciò che davvero desiderava; ha battuto lo stesso tasto finché non è stato pienamente soddisfatto – il titolo che mancava finora era Háború és háború del 1999, che arriva adesso nella traduzione italiana di Dora Varnai, Guerra e guerra, sempre per Bompiani. “Four books that make up one book, then; a kind of purgatorial gestalt”, secondo Paris Review, da parte di un autore, che così confessa: “…per lungo tempo ho creduto che la realtà fosse il Castello di Kafka, e la Bibbia Sotto il vulcano di Lowry… Pensavo di scrivere un unico romanzo e poi di vivere in piccoli villaggi, in mezzo ai più poveri: questa è la vera vita” dice a Adam Thirlwell.
Guerra e guerra: ci è subito famigliare il protagonista, György Korin, quarantaquattrenne archivista di provincia nell’Ungheria degli anni Novanta, che trova di colpo insopportabile la sua vita e teme di perdere la testa in senso tutt’altro che metaforico: non si fida della tenuta delle vertebre del collo; sembra già di primo acchito parente al Professore, che nel Barone è impegnato a trasformarsi in eremita per azzerare il proprio pensiero, al musicista di Melancolia col suo filosofeggiare nientizzante, all’immobile Dottore di Satantango. Vero è che Korin appartiene più alla razza dei Godot immiseriti e stravolti piuttosto che a quella dei poveracci tout court che si rovinano aspettando qualcuno invano o addirittura non aspettando più.
Prologo. Facciamo la conoscenza dell’archivista in un lungo e virtuosistico pianosequenza: entra ubriaco in un bar, e racconta, disordinatamente, la fine della meraviglia del mondo, e di ogni credenza nel soprannaturale, a un barista che si rivelerà un finto prete – non esistono, forse, preti veri.
La tirata, che si abbevera a Nietzsche o a Dostoevskij, è costituita di parole e frasi che finiscono in un ossessivo loop alla Thomas Bernhard; sullo sfondo del locale, intanto, sotto le luci al neon, molto teatralmente – o cinematograficamente – si accoppiano due vecchi e vizzi barboni; il tutto finisce con uno sparo e una fuga. Partono i titoli di testa.
L’archivista si mette in viaggio, verso Budapest – e poi verso New York che gli sembra la giusta destinazione per comunicare la sua scoperta – recando con sé “l’enorme fardello della futilità umana”, un antico manoscritto scovato e trafugato, e l’angoscia di trovarsi in una società pericolosamente inselvatichita – vedi l’allucinata scena del ponte con la banda di ragazzi criminali che lo lascia andare, dopo averlo ferito a un dito con una lametta, per mettersi a tirare ai treni con la fionda.

L’eco di altre Americhe letterarie, viste e scritte a partire dalla Mitteleuropa, si confonde con le peripezie dell’archivista sbarcato in Usa per rinascere e morirvi, e lascia il campo agli scenari di quella sorta di Vangelo che Korin si è cucito nella fodera del cappotto per regalarlo al mondo via Internet. Il manoscritto – autentico libro nel libro – mescola quattro tempi diversi, e quattro teatri di perpetua guerra, Creta nel minoico come la Venezia del XV secolo, dove quattro uomini si confrontano con il demoniaco Mastermann.
C’è una sorpresa finale (non spoilero). Il viaggio dell’archivista uscirà dalla pagina per entrare nella realtà: Krasznahorkai porterà il suo Korin, complice un celebrato igloo di Mario Merz, in un museo di Sciaffusa, Svizzera. Per una ulteriore beffa – reale pure questa, come apprenderemo in postfazione. Ma tutto ciò tocca scoprirlo al lettore, che avrà la voglia – e a tratti la pazienza – di mettersi nelle scarpe di Korin e di assecondare gli estri ossessivi dello scrittore ungherese.
Prepariamoci all’Apocalisse – o al suo annuncio – sembra dirci Krasznahorkai, che ha in sé la convinzione o il fondato sospetto – e questo gli permette di essere grottesco e spiazzante senza sforzo – che sia già avvenuta. Per questo molti (tutti?) i suoi personaggi ci sembrano affidati alla corrente di una vana speranza, quasi postumi di se stessi.
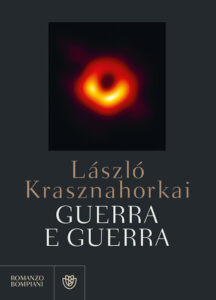
A margine. Mentre consigliamo un’immersione nel black humour con nobilissimo pedigree di Krasznahorkai, rimandiamo a un prossimo approfondimento i suoi rapporti con il regista Béla Tarr, cui ha fornito copioni reinventati dei romanzi, oltre che soggetti originali. Ma per apprezzare subito un momento di puro Krasznahorkai/Tarr in pellicola, suggeriamo di cliccare qui.
È il pianosequenza iniziale di Werckmeister Hármoniák, dura dieci minuti e riprende, alla chiusura di un bar, la ormai famosa lezione di cosmologia del fragile sognatore Valuska: il film del 2000 è tratto da Melancolia e fa da buona porta d’entrata agli universi paralleli dei due grandi ungheresi.

I LIBRI László Krasznahorkai, Guerra e guerra, Satantango, Melancolia
Le immagini sono tratte da Werckmeister Hármoniák e Satantango di Béla Tarr





