“Tutti gli uomini vivono – la vita è il modo d’essere degli uomini, che si svolge nel tempo. Eppure pochi sono gli uomini che si sono chiesti seriamente che cosa è questa vita ed in che modo deve viversi”. È l’incipit di un lavoro di Giorgio Colli. Mi è tornato in mente mentre leggevo Viaggio sentimentale di Viktor Šklovskij, testimonianza indispensabile a tutti coloro che ancora si domandano come e perché la seconda rivoluzione più importante nella storia dell’umanità si sia trasformata prima in farsa e poi in tragedia.
Scrive Šklovskij: “Un uomo è addormentato e sente suonare il campanello del padrone. Sa che deve alzarsi, ma non ne ha voglia. E allora si inventa un sogno e ci mette dentro questo campanello, fornendogli un’altra motivazione – che sta sognando le campane del mattutino, per esempio. La Russia si è inventata i bolscevichi come un sogno, come una giustificazione all’abbandono del campo di battaglia e alle ruberie; i bolscevichi non hanno colpa di essere stati sognati”.
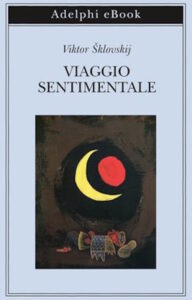
Tralascio la nota a commento. Se googlate il suo nome viene fuori un delirio: non aveva ancora venticinque anni e aveva già scritto cose fondamentali sulla teoria della prosa, perso i capelli, buscato una ferita al ventre sul fronte russo-polacco, organizzato un reggimento di autoblindo a Pietroburgo, cospirato da socialista rivoluzionario contro i bolscevichi, organizzato la ritirata dalla Persia, tenuto lezioni su Tolstoj e Sterne, organizzato seminari, inventato riviste e circoli letterari, amato immensamente la vita, la rivoluzione e, nonostante tutto, il suo sciagurato Paese. (Dimenticavo: salvato la ghirba dai tentacoli della Ceka, fuggito in Finlandia, lavorato a Berlino, tornato in Russia divenuta URSS, e infine scampato alle purghe staliniane).
Se i nostri giorni fossero numerosi come le pagine sulla rivoluzione russa, i Matusalemme sciamerebbero a frotte. Una bibliografia sterminata. Tutto e il suo contrario. I lavori seri, la propaganda, l’agiografia e le immancabili volgarità di regime, queste ultime come da tradizione stilate per nobilitare crimini e misfatti. Per mia fortuna sono solo un viandante. Della storia, scienza che pur m’appassiona, mi limito a scrutare l’ordito del tappeto dove s’acquatta la grande narrazione; la battaglia di Borodino ha per me qualche rilievo giusto per via di Andrej, l’innamorato di Nataša. Anche Šklovskij soffre le pene d’amore: “La mia storia d’amore con la rivoluzione è profondamente infelice” scrive nel 1922 a Gor’kij dalla Finlandia dov’era fuggito per evitare l’arresto. (È l’aprile del 1922, i giochi sono fatti e a Mosca s’apparecchiano i processi. Non saranno gli ultimi, come sappiamo).
Lasciamo allora la storia agli storici di professione. Abbandoniamo la via sicura della grande storia (quella che ha superato l’esame del tempo) e chiediamo aiuto alla letteratura, scienza solo apparentemente improbabile e assai più generosa: a volte basta non dico un capitolo ma un paragrafo per fare luce. Chi conosce Šklovskij narratore sa che a lui, mano lesta paratattica, basta una sola frase per rendere palpabile l’orrore. Perché le rivoluzioni, probabilmente tutte le rivoluzioni, si nutrono di orrore. In quella russa l’orrore assume la veste della ferocia agita con ottusa indifferenza, quando gli uomini ammazzano senza bisogno di provare odio.
Una testimonianza tra storia e narrazione la offre John Reed. C’è l’infinita pazienza del popolo russo che si muta in furore nel reportage del giornalista americano corso con la moglie a San Pietroburgo per assistere allo spettacolo dell’inaudito. L’uomo che a dar retta a Trockij “sapeva vedere e ascoltare”, racconta gli avvenimenti accaduti nel novembre del 1917 in presa diretta, come se stesse girando il film che cinquant’anni dopo venne poi realizzato. Una storia di lotta e di speranza dove tutto, anche l’impensabile, sembra possa diventare possibile; il racconto dei sentimenti e delle sofferenze vissute da soldati, operai, contadini. L’esito di quello che a Reed, fervente socialista, appare essere un nuovo corso della Storia scritta con la esse maiuscola, per sua fortuna gli fu risparmiato. Di ritorno da un viaggio a Baku morirà di tifo a Mosca nel 1920.
Ma John Reed, nonostante l’emozione autentica delle sue pagine, non è un narratore. Il giornalista di razza informa, testimonia, documenta. Nel migliore dei casi offre una sintesi e un’interpretazione dei fatti: è successo questo; in questa successione; con questo rapporto di cause ed effetti; cui ne discende che, punto. Il narratore invece stravolge la realtà. La forza sino a violarla, inventa e crea: personaggi, figure, situazioni e contesti per meglio onorarla, restituendocela palpitante e credibile grazie alla forza deformante della falsificazione. Come avviene nei processi di stampa dei contenitori in metallo per alimenti, la distorsione programmata consente la corretta lettura delle immagini e dei caratteri una volta che il contenitore verrà stirato e poi riempito. Così come il musicista esegue un trasporto di tonalità, il narratore trasforma il particolare in universale, rende tangibile l’incredibile e percepibile l’inaudito. La nostalgia di Odisseo prigioniero di Calipso, il dolore per la morte del piccolo Hanno, la smania di Bergotte morente per la Veduta di Delft, sono la nostalgia, il dolore, il desiderio dell’umanità.
Anche Isaak Babel’ è un giornalista. Partecipa come corrispondente alla guerra sovietico-polacca del 1919-20. Viene assegnato all’armata a cavallo del mitico Semën Michajlovič Budënnyj, il grezzo generale adorato dai soldati per il coraggio. Trasforma le pagine del diario di guerra in brevi racconti che verranno pubblicati con il titolo L’armata a cavallo. Li lessi che non avevo vent’anni, e il ricordo di quelle pagine è ancora nitido nella mia mente. Nell’autobiografia scrive: “Soltanto nel 1923 imparai a esprimere i miei pensieri in modo chiaro e non troppo prolisso. Allora ripresi a scrivere”. Balle cinesi. Babel’ è il genio che scrive come se incidesse le frasi nel cuoio della sella (l’immagine purtroppo non è mia). L’armata a cavallo è il capolavoro da mettere in mano a chi intende iscriversi a un corso di scrittura creativa; nei giorni pari studiano il paratattico Babel’, quelli dispari l’ipotattico di Proust; e così forse rinuncerebbero.
Al di là dei meriti stilistico-formali, L’armata a cavallo è uno dei primi manufatti letterari in cui il protagonista è l’atrocità della guerra. Il racconto della ferocia privo di retorica, di concessioni all’ideologia né al così detto romanticismo rivoluzionario. Solo grazie all’intervento di Gor’kij fu possibile pubblicare il libro. Quando però Stalin impose agli intellettuali il morso del realismo socialista, a Babel’ non rimase che praticare la letteratura del silenzio: nel corso della campagna stalinista contro il “formalismo” nell’arte, Babel’ venne criticato per un presunto “estetismo” e scarsa produttività. Dichiarato “nemico del Pcus e del potere sovietico” verrà fucilato nel 1940 su proposta di Lavrentij Berija controfirmata da Stalin.
Questa piccola nota sugli scrittori che narrano della rivoluzione che divenne controrivoluzione si conclude con Nina Nikolaevna Berberova. Il teatro della sua guerra non è la Polonia di Babel’, non l’Ucraina, e neppure la ritirata dell’esercito ai confini dell’ex-impero zarista con la Turchia e la Persia di Šklovskij. Il fronte dove combatte la guerra alla fame, al gelo, alle privazioni e alla paura che diventa terrore, è la città di San Pietroburgo. Il racconto di quegli anni è raccolto nella prima parte dell’autobiografia intitolata Il corsivo è mio. La Berberova proviene da un ambito familiare alquanto diverso da quello di Šklovskij, nato in una famiglia della piccola borghesia ebraica. Anche l’orientamento o meglio l’ispirazione politica li rende distanti e diversi: la Berberova ha 16 anni nel ’17 e per ragioni personali e familiari – il padre è un alto funzionario dello Stato – la rivoluzione non può che subirla; Šklovskij invece nel’14 interrompe gli studi di filologia, si arruola volontario, partecipa alla rivoluzione di febbraio del ’17 e diventa membro del Partito Socialista Rivoluzionario.
Eppure il racconto degli anni che vanno dal 1920 al ’22 si sovrappone perfettamente. Stesse frequentazioni culturali, stessa passione per l’arte, la scrittura, la sperimentazione, la poesia; stessi incontri, amicizie, idiosincrasie; stessa fame, privazioni, paure. A San Pietroburgo in quegli anni tutti incontrano tutti: Šklovskij, Jakobosn, Pasternak, Blok, Majakovskij, la Cvetaeva, Belyj, Chodasevič, i “fratelli di Serapione”… un immenso patrimonio spirituale prim’ancora che artistico e culturale, che la contro-rivoluzione bolscevica prima affama, poi costringe al silenzio, e infine distrugge nei gulag. Gli intellettuali sono nemici del popolo. Rappresentano (per definizione) un pericolo per il regime. Verrebbe da precisare, qualunque esso sia.
Scrive la Berberova: “Che ne facciamo della visione tragica della vita in cui siamo stati educati? Del tragico periodo della nostra storia? Del destino della mia patria, della mia generazione e infine del mio destino personale? Mi sembra che una risposta ci sia: la tragedia mi fu data come terreno, come base di vita: noi nati tra il 1900 e il 1910, siamo cresciuti nella tragedia che a suo tempo è entrata in noi, per così dire l’abbiamo bevuta ce ne siamo nutriti e l’abbiamo assimilata, ma ora che la tragedia è finita ed è iniziato l’epos io ho il diritto, dopo aver vissuto una vita, di non prendermi troppo sul serio”.
Ritorno nuovamente all’incipit di Giorgio Colli: “Tutti gli uomini vivono – la vita è il modo d’essere degli uomini, che si svolge nel tempo. Eppure pochi sono gli uomini che si sono chiesti seriamente che cosa è questa vita ed in che modo deve viversi”. Un’affermazione (o piuttosto una domanda?) che mi dà un disturbo simile a quando un organo del nostro corpo che avevamo scordato di possedere dà un inatteso segno di sé. Non un dolore vero e proprio, ma un certo qual fastidio, come una sorta di premonizione. Ci ricorda che l’orrore può suonare anche alla nostra porta di casa; anche se pensiamo di essere al sicuro. Soprattutto se diamo per scontato il nostro modo di vivere e di essere, la saldezza inespugnabile della nostra società (abbastanza) libera e (abbastanza) liberale.
La domanda che Colli si poneva negli anni Quaranta del secolo scorso potrebbe oggi essere riformulata così: quanti sono gli uomini disposti a battersi per un principio di libertà quando in cambio della libertà viene loro assicurata pancia piena e sicurezza del futuro? Quanti sono gli uomini che per indifferenza, pigrizia, quieto vivere, preferiscono non sapere, non giudicare, non ricordare?
Nella foto di aprtura, l’immagine in apertura: Paul Klee, Forte sogno (particolare)





