Ventiquattr’ore della vita di un immaginario paesino gallese, Llareggub – che letto al contrario si può tradurre con “un cazzo!” – dove tutto o quasi è affidato alla voce interiore dei suoi abitanti, a partire da un Virgilio immoto, il cieco Capitan Gatto, che dialoga con i suoi uomini morti in mare; e proseguendo incontreremo Mrs Ogmore Pritchard, due volte vedova che non ha mai smesso di tiranneggiare in sogno i mariti, e Willy Nilly, postino indiscreto, l’inquietante Lord Cut-Glass con i suoi 66 orologi diversi che dovrebbero schermarlo dalla morte e la promiscua Polly Garter che si strugge d’amore solo per chi non ha più, il piccolo e tenero Willy Wee…
Sono una sessantina i personaggi, parecchio strambi – essendo la stranezza in qualche modo segno di una irriducibile innocenza nei confronti della Storia e nel contempo di un’ingenuità “politica” dell’autore -, e trasmettono quasi a staffetta un’ondata di parole e pensieri, visioni e incubi, in un testo poetico che richiama il modello joyciano dell’Ulisse e si incastona, con la sua vena proteiforme e lunatica, tra i tanti cambi e mix di stile, dall’epica alla rima per bambini, al termine della vita bruciata in una fiammata di Dylan Thomas.
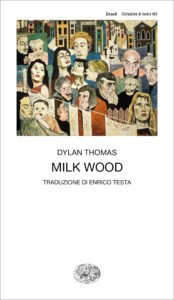
È uscita da Einaudi la nuova versione italiana di Under Milk Wood – il radiodramma commissionato dalla BBC e pubblicato postumo benché rappresentato in prima a New York, nel maggio del 1953, quando Thomas era ancora in vita e recitato dal poeta di Swansea come voce narrante e Rev. Eli Jenkins – e non si chiama più Sotto il bosco di latte, ma Milk Wood e basta.
Spiega il traduttore, il poeta e professore Enrico Testa, si tratta di un toponimo e l’anglista Carlo Izzo, autore di una versione storica, aveva esagerato nel rendere in italiano non solo il titolo ma anche i nomi (improbabili ed evocativi) degli abitanti del paese.
La traduzione di Izzo – anche assai meno sexy – presa in esame da Testa viene ricondotta a un introvabile libro edito da Guanda nel 1992, ma è di certo anteriore, dato che noi l’abbiamo letta per la prima volta in un Oscar Mondadori datato 1972 – unita a Il Dottore e i Diavoli – e ripescata da un Einaudi del 1961.
È un destino che, anche lasciando perdere Bob, il bardo Nobel di Duluth, il nome di Dylan Thomas si mescoli, nella percezione di un vecchio lettore, con qualche cosa di rock.
Troviamo proprio all’inizio del testo, mentre un’alata voce narrante descrive la notte sulla “piccola città” gallese quel “senza luna, senza stelle e nera come una Bibba” che sono il titolo e un brano di Starless and Bible Black. Ossia del sesto album dei King Crimson di Robert Fripp (1974), ma Starless è pure il titolo di un outtake conservato per il disco seguente, Red (sempre 1974), dodici minuti su un peraltro laconico testo di Richard Palmer James (quello dei Supertramp) – l’uomo che sostituì il prezioso e barocco Pete Sinfield.

Che cosa il Re Cremisi, prima di “disbandare” tra l’altro, volesse recuperare di Thomas in un’atmosfera di musica elettrica e dura quanto mai, spigolosa e percorsa (nel pezzo strumentale) da fratture ritmiche e sonore, cercheremo dunque di capirlo al contrario, usando il prog furente di sua maestà Fripp per soundtrack, mentre proseguiamo la lettura e in parte recuperiamo nella memoria le suggestioni di Milk Wood, che per umore ci sembra in realtà più vicino a una fantasia dei primi Genesis.
Ma a proposito: perché la notte thomasiana è Bible black ed è proprio così, con Bible aggettivato, visto che lo ripete altrove nel testo? Una spiegazione porta dritto alla condensazione del linguaggio poetico: capiamo subito che siamo al buio e nel contempo abbiamo una connotazione religiosa del paesino. La seconda, che non esclude la prima, riconosce una tipologia di nero delle origini, atavico e pure alquanto minaccioso, tra le tante specifiche di black e di darkness, di oscurità che attraversano i versi dell’uomo di Swansea. Milk Wood, che parte nel buio della notte, si apre al giorno e richiude in chiasmo all’imbrunire, sulla notte che cade, nuovo palcoscenico per i suoi personaggi, in cui significativamente, come luce e ombra, impariamo che s’incontrano e dialogano i vivi e i morti.
Il Bible black e il crowblack di Llareggub formalmente potrebbero arrivare da lontano: derivare dal sunblack e fly-black di un abbozzo di testo nato in un viaggio italiano di Thomas, un soggiorno all’Elba nel 1947, dov’era già impegnato con l’idea di un radiodramma.
Il testo inglese di Milk Wood – peccato non sia a fronte nel volumetto Einaudi – è però facilmente rintracciabile sul web, come pure una lettura storica, che emoziona e, per cosi dire, illumina.
***
I’ll die like Dylan Thomas/ To seizure on a barroom floor

Dunque. Dylan Thomas bevve troppo alla White Horse Tavern, a Manhattan, dov’era arrivato per un tour di conferenze e letture, il quarto in terra americana dal 1950; collassò al Chelsea Hotel, mitico posto sfigato, stanza 205, e morì al Saint Vincent Hospital, in cui giunse già in coma, all’una di pomeriggio del 9 novembre del 1953: aveva 39 anni, festeggiati malamente in viaggio. E però la fine del gallese è avvolta in dubbi e congetture, in cui si citano lo smog incredibile di New York in quei giorni e il diabete del poeta, i problemi respiratori e un fegato piuttosto sano ad onta di una vanteria sui whisky ingollati (un record di 18), per non dire delle iniezioni di morfina dispensate da un medico premuroso e ambiguo, il dottor Feltenstein.
Comunque la diagnosi fu che Dylan Thomas morì per …a swelling of the brain caused by pneumonia and poor oxygen supply. E tutto termina qui. La moglie Caitlin Macnamara è già arrivata di corsa all’ospedale, e ha detto davvero: “Is the bloody beast still alive?”, prima di crollare e farsi dieci giorni nella clinica psichiatrica Rivercrest di Long Island. L’ultimo respiro di Thomas è raccolto da un altro poeta, pure lui accorso di fretta, John Berryman. Entrambi, Macnamara e Berryman, impediscono di scendere al tasso alcolico di questa storia.
Mi ricordo di aver letto la famosa frase della moglie nella prefazione di un Oscar Mondadori del 1971 che raccoglieva il meglio di Dylan Thomas. “Is the bloody beast still alive?”. Avevo comprato il libro da ragazzo. E peccato che di quell’Oscar, preso più che altro per vedere a chi Bob D. aveva rubato il cognome – ma era leggenda -, tenni a mente solo una poesia, spaventosa e spettacolare, Love in Asylum, e finsi di comprendere le altre.
Oggi ho ascoltato Conor Oberst e Phoebe Bridgers che cantano:
I’ll die like Dylan Thomas/ To seizure on a barroom floor
E poco più avanti:
I’ll take a shower/ At the Bates Motel
Sì, ma che cosa c’entra il bar di Dylan Thomas con le stanze a nolo di Psycho? Forse niente, forse sono finiti insieme in un elenco di spazzatura pop. O no?
“It’s kind of got a ‘doo, doo, do doo doo doo’ melody going on – così Pheobe spiega la canzone a Rolling Stone – but the lyrics are like heinous…” Il video del track, girato da Michelle Zauner dei Japanese Breakfast, aiuta a capire: ci porta all’interno dell’immaginario Better Oblivion Community Center, una sorta di setta sedotta dai riti farlocchi e un po’ new age della realtà virtuale, e suggerisce che c’è bisogno di scappare, di togliersi le tecno-bende della cecità contemporanea, affidandosi magari alle parole di un veggente ubriaco – e alla peggio, come la bloody beast, stramazzare sul pavimento di un bar, o lasciare stoici, nella variante Bates, che il sangue puro scorra nello scarico della doccia. Però, pensandoci, magari c’è una terza via: battersela alla gallese e rifugiarsi tra gli strambi di Milk Wood…
Credit: “Dylan Thomas – Light breaks where no sun shines” by Jacob Whittaker is licensed under CC BY-NC-SA 2.0





