Per caso, ho incominciato Niente di vero (o di Vero con la maiuscola?) di Veronica Raimo (Roma, 1978) da metà libro, più esattamente da pag. 82: l’ho trovato aperto a quella pagina su un iPad preso in prestito. Letto un paragrafo, non sono riuscito a fermarmi: mi sono divertito e ho riso da solo, come da fascetta di Zerocalcare, e quando ho cercato di frenare un po’ e di alzare un sopracciglio, l’ho abbassato subito, preso dalla foia del voyeur che spia nelle segrete vite altrui, per finire poi immediatamente portato a spasso e irriso da un racconto/confessione – è confessional ma senza scopi liberatori o didattici – candido e reticente, così come è di solito, o almeno si diceva una volta, sua maestà la letteratura – l’unico valore resistente, non sfanculato, in Niente di vero – letteratura praticata da una persona pigramente svogliata ma molto molto per finzione, su pagine dove scatta un’acuta intelligenza delle cose che arrivano, si fermano un attimo, passano, muoiono e chissà se mai tornano.
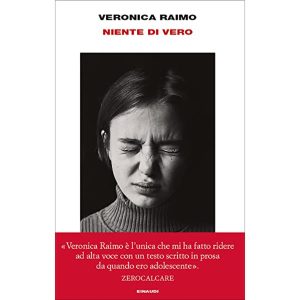
Leggere da metà e poi ripartire dall’inizio – che ha qualcosa di più pacato, o di meno brusco e nervoso, nell’accogliere le avventure di una bambina – mi ha aiutato a capire che Niente di vero non è un memoir addobbato da tradizionale romanzo di famiglia (dalle stelle alle stalle, dalla Ginzburg alla Bignardi) per quanto sveli o adoperi lessici privati, né è la controfigura di un costruttivo Bildungsroman (lo è forse ma tutto scassato).
Poi, ho percepito più nitidamente nel romanzo di Raimo – è un romanzo tout court e ciò che racconta potrebbe essere, e lo si lascia intendere con civetteria, tutto inventato – uno sgradevole sentimento universalizzabile cioè il senso della vita come un passaggio in cui siamo tutti inessenziali e potremo essere incapaci e senza qualità, come si presume attraverso l’understatement insistito della protagonista, e andrebbe tutto bene (o male o così così) lo stesso, mentre compiamo riti stupidi, tra parenti e amici e amori che ripetono le stesse frasi in loop, intanto che noi cerchiamo, magari divisi tra Roma e Berlino, chiusi in una reggia o liberi in una topaia, di essere comfortably numb, piacevolmente ottusi o almeno troppo distratti per soffrire troppo.
La protagonista del romanzo è infatti smemorata e spesso addolorata, anche se non prende quasi mai su di sé il tono del dolore. Meglio la sprezzatura, l’ironia, il sarcasmo, lo stare in stand by alternato all’indifferenza di un vaffanculo. Anche perché poi Vero, Verika, Straccetto per dire tre dei suoi tanti soprannomi (la protagonista del romanzo che non ha un nome preciso!) si riscatta sempre, e ha un attimo magico in cui le riesce tutto, ed è la scrittura che le riesce in primo luogo, naturalmente.
Niente di vero dice che sua maestà la letteratura, lontano dalle più barbose e cervellotiche rivelazioni, dai drammi parentali ed edipici, dai diari di adolescenti impegnati o secchioni che ricostruiscono di tutto, dalla prima gita a Chiasso alla vita sessuale di loro nonna, è uno dei pochi passatempi divertenti e forse anche portatori di libertà. Questo se un testo funziona (e questo sì).
A margine. Mi annoto che vita e scrittura condividono un’alleata potente, stretta parente della libertà: la precarietà, condizione a un tempo infida e esaltante. Scrive per esempio Raimo in una storia compiuta anche se di cinque righe: “Il romanzo l’ho finito nei centotrenta metri quadri dell’appartamento vuoto di una coppia che si era appena separata. C’erano solo un letto, una scrivania e gli scatoloni già imballati con scritto: Ship to Sarah. Sarah si era trasferita a San Francisco. Sulla scrivania c’era una sua struggente lettera d’addio e le bollette da pagare. Ho pianto sulla fine di un amore prima del suo destinatario” (nel caso una storia così non intenerisse il plurinominato e fitzgeraldiano Amory Blaine, si potrebbe venderla insieme a tutto il romanzo al Monroe Stahr/De Niro de Gli ultimi fuochi).
IL LIBRO Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)





