Tra l’ottobre e il novembre del 1922, prima sulla rivista inglese The Criterion (600 copie) poi sull’americana The Dial, e quindi in libro a dicembre, appare The Waste Land di T.S. Eliot: il poema ha dunque cent’anni (da poco), e questo di per sé non dovrebbe significare niente. In un vecchio disco di vinile, o forse adesso pure su Spotify, ascolteremo di nuovo Eliot che lo recita con il suo accento di yankee che finge di essere nato a Oxford.
“April is the cruelest month…” e noi di nuovo, convenendo, diremo al solito “ora sappiamo perché”, e così accadrà ad altri lettori tra un secolo nel bicentenario de La Terra desolata o della Terra devastata secondo una minoritaria versione italiana che nell’aggettivo segnala l’importanza del dissesto. Ma il poema è stato tradotto anche come Terra guasta o Paese guasto, su suggestione dantesca (XIV canto dell’Inferno), per assonanza con l’inglese o per significato, la terra infatti sarebbe wasted per consunzione interna. L’aggettivo desolato non dispiacque a Eliot in occasione della storica versione delle Poesie curata da Roberto Sanesi (Bompiani 1961, poi diffusa come un best of negli Oscar Mondadori).
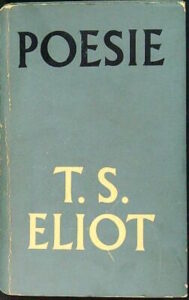
Un secolo cos’è mai. Per la poesia, il tempo non conta e quindi non passa e nemmeno esiste. Così almeno ci suggerivano da studenti i docenti crociani, essendo la poesia un vivo sentimento di un singolo (qui un borbottio di un uomo di malumore, Eliot dixit) ma liberato e congelato nell’oceano dell’universalità.
La do per buona, ai vecchi insegnanti, nel caso di Eliot perché, ripescando dal manifesto letterario Tradition and Individual Talent (1919), egli stesso dice che la poesia non dovrebbe essere che an escape from emotion e che il poeta-catalizzatore “può lenire la propria sofferenza personale proiettandola verso un valore concettuale ed emotivo universale” (me lo insegna Fabiola Notari in Ritorni Danteschi). Oppure, argomentando in modo diverso, concordo sul fatto che “…Eliot è ormai troppo penetrato nel DNA poetico del ’900 per individuarne l’originario apporto gametico, …indistinguibile da ogni esperimento di poesia contemporanea” (un astuto Alessandro Zaccuri, su L’Avvenire). Servono forse a questo paradosso gli anniversari, cioè a rinfrescare la memoria sull’eredità di capolavori che abbiamo in ogni modo, in originale o in altre forme, sempre sott’occhio, come la lettera nascosta in bella vista di Edgar Allan Poe?
Io parto a rileggere The Waste Land da quel verso nel finale, ottundente per bellezza e compressa disperazione (la terra disperata) – “These fragments I have shored against my ruins” – in questo verso, prima che Eliot finga di mormorare quasi a casaccio parole di confusione mentale e di beatitudine (“Hieronymo’s mad againe” e “Shantih Shantih Shantih”), si richiama l’esatto tempo storico del poema, mentre si dichiara la nostra sempiterna condanna all’alienazione.
È il tempo del disastro da cui Eliot vorrebbe in qualche modo trovar riparo – credo sia rappresentato dal dopoguerra di una Guerra mondiale, che ha visto pure la Rivoluzione d’Ottobre, ma in accezione più ampia è la perdita irrimediabile della chiave d’accesso a un qualsiasi senso, essendo noi scaduti from ritual to romance – ed è quindi il tempo dell’uomo che sa tutto ma il suo tutto è un armamentario scassato e gli è perciò inservibile, come se cercasse l’ora su un orologio rotto in un giorno di post Apocalisse.
Per questo ai compleanni dei secoli, festeggio l’amara consolazione che siamo ancora lì, in quelle pesti, con Eliot, e ancora ci resteremo, leggendo un poema fatto di umanissima realtà, nonostante il disumano Eliot, asservito all’understatement più aristocratico, ostenti di aver semplicemente espresso un certo fastidio – cosa quest’ultima che lo snob Montale ha sentito consona o ha imitato benissimo.

Comunque. Eliot è grande e persino un po’ ridicolo – quando si ritrae nella figura di un Tiresia irriso dai contemporanei – non appena prova a ghiacciare la catastrofe appena accaduta nella sua palla di vetro, frantumata e fintamente imperfetta (ah, che bravo il miglior fabbro!) come quella dei grandi che ha evocato e i cui versi ha shakerato, da Omero a Dante, da Shakespeare a Baudelaire (gli basta un Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!), eguagliandoli mentre finge di chieder loro un aiuto.
Per essere chiari. Quanti hanno letto The Waste Land senza occuparsi troppo dei suoi ingredienti, dei “frammenti”? Si può passare una vita per impadronirsene e in fondo Eliot stesso non voleva che lo capissimo poi troppo: richiesto di dare spiegazioni sul suo lavoro, da poeta elitario qual era, buttò giù due notarelle e basta, concedendosi al minimo sindacale. Sul King Fisher, il Graal e il Ramo d’Oro, il famoso saggio di Jessie Weston…
The Waste Land funziona lo stesso. Mi basta a commuovermi finché campo – metto cioè a disposizione la mia miseria di tempo di lettore – quando Eliot accenna alla défaillance del ragazzo dei giacinti e di nuovo ho timore della “morte per acqua” – non per niente il “far argine”, il “puntellare” del famoso verso sulle rovine è un I’ve shored in cui credo ci sia il seme protettivo di shore, la costa – e non mi riuscirà mai di immaginare che cosa vuol dire camminare tra gli infimi dei tebani morti, compiangendo ancora una volta un posto e un luogo in cui Tiresia, il grande Tiresia che è stato sia uomo sia donna – Tiresia che, come accennato, forse è l’alias di Eliot e forse il personaggio principale del poema all’interno di una spettacolare polifonia -, conosce il futuro degli altri come tutti gli uomini navigati e i pettegoli, e non ha bisogno di usare i suoi super poteri e di divinare profeticamente per anticipare che cosa accadrà per esempio alla giovane impiegata che aspetta il suo amante cafone, etc. etc.; ovvio che lui se la scopa.
Mi accorgo che tendo sempre a rendere romantica e irrazionale più di quanto sia l’ispirazione che porta a The Waste Land, cioè al misto di Modernismo già Post Modern dell’Eliot di quegli anni, diviso tra le indeterminatezze del soggiorno inglese, il rischioso desiderio di fare il mestiere di poeta e la concreta chance di mollare il colpo e salpare per Harvard, dove lo attende una cattedra da filosofo. Banalmente, da ragazzo, io cercavo nell’opera, e in particolare nel lamento della donna malata, l’eco dei privati e condivisibili disagi di Eliot, perseguitato dai suoi, di nervi, e da quelli della moglie Vivienne/Vivien, musa casuale destinata più tardi al manicomio. Sono i fatidici momenti in cui Eliot, vittima dell’indecisione e delle fatiche del poema in gestazione, stabilisce con l’analista che deve smettere di scrivere per almeno tre mesi e poi invece rimane shockato dalla lettura dell’Ulisse, scoprendo che Joyce ha già fatto (meglio?) quello che stava facendo lui. Così almeno avevo desunto spiluccando una di quelle belle enciclopedie della Utet che una volta ficcavo in libreria con l’idea che potesse servire avere in casa, chissà mai, un bigino completo di tutta la letteratura britannica da Beowulf agli angry young men del teatro (quei bigini erano l’equivalente di Wikipedia?). Per la cronaca, l’enciclopedia, acquistata nel 1995, è la Storia della civiltà letteraria inglese (con dizionario) curata da F. Marenco.

Concludo ritornando all’inizio. Avevo dimenticato di rileggere l’esergo in latino e greco di The Waste Land riguardo a ciò che desidera la Sibilla Cumana – apothanein thelo: voglio morire – e si capisce che il tempo e il mondo su quella soglia del testo e anche oltre si può fermare davvero anche in un altro modo, cent’anni o mille anni dopo…
La traduzione che ho avuto in mano o piuttosto in memoria per queste righe è quella di Sanesi e ho serbato tra i miei, di fragments, un antico corso di angloamericano tenuto alla Statale da Mario Corona, di cui ricordo volentieri la curatela contestata di un Meridiano Mondadori dedicato a Jack Kerouac (2001). Ricordo molto più che volentieri i miei compagni di banco, Nicola Crepax e Gabriella Tonzar. L’ultima versione in italiano di The Waste Land credo sia quella edita da Ponte alle Grazie, firmata dalla poetessa Sara Ventroni.
A margine Eliot, Nobel 1948, viene irriso insieme a Ezra Pound da danzatrici di calypso in un testo di un più recente premio Nobel americano (2016), Bob Dylan: la canzone è Desolation Row, e data al 1965. Notava Fernanda Pivano in B.D. Blues, ballate e canzoni (Newton Compton, 1972) che Dylan intendeva sfottere i vecchi T.S. ed Ezra poiché nei loro versi non si occupavano della realtà ma di poetiche quisquilie. Secondo Nicola Licciardello (Esoterismo fra avanguardia e globalizzazione), la canzone di Dylan è solo la prova che “di essi (Pound e Eliot, ndr) tuttora usiamo le stimmate di pensiero. Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain’s tower”. A proposito: su che cosa staranno litigando i due? Mi piace pensare che sia sulla fine del mondo, che per T.S. avviene “not with a bang but a whimper” (The Hollow Men, 1925), mentre Ezra ribatterà, nel primo dei famigerati e drammatici Canti Pisani, dopo il suo personale tracollo, “yet say this to the Possum: a bang, not a whimper, / with a bang not with a whimper” (Cantos, LXXIV).
The Possum! Frattanto i primi Cantos del miglior fabbro sono apparsi in una versione molto letterata ed elegante di Patrizia Valduga per Mondadori. Siamo ancora tutti lì…
Nella foto grande, particolare di un disegno di T. S. Eliot by Simon Fieldhouse
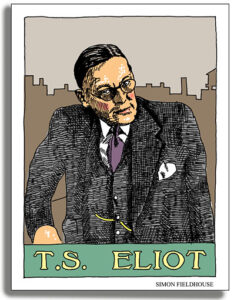
Credit: “I had not thought that death had undone so many” by Simon Knott is marked with CC0 1.0.”T. S. Eliot” by Sneh Vatsa is licensed under CC BY-SA 4.0. – LIFE images





