Un uomo “considerevolmente anziano”, abbastanza da dirsi vecchio, che ha le mani tremanti per aver tanto afferrato della vita, passeggia di notte con i suoi cani nella fastosa via romana dove un po’ fortunosamente si è trovato ad abitare.
È l’ultimo giro prima di dormire ed è occupato dall’eco di una discussione oziosa su chi merita il primato tra cani e gatti. Ciò porta all’uomo il ricordo di tante bestie amate e perdute e di un’esistenza intera, libera ma difficile, fatta di svolte impulsive se non di scelte coraggiose, e segnata dagli amori con “la ragazza dei boschi e del mare” o, nella maturità, con una donna di nome Laura.
Dunque. I cani sono meglio dei gatti per la loro fedeltà persino ottusa – ma non è invece quest’ultima una sorta di preveggenza, un perdono preventivo del padrone? Certo, i gatti vanno dove vogliono, e però i cani sanno sempre dov’è l’“immenso e buio gelido Nord” in cui ci aspetteranno. Sono, detto in altre parole, degli psicagoghi, e di uno psicagogo forse ha bisogno l’uomo “considerevolmente anziano”.
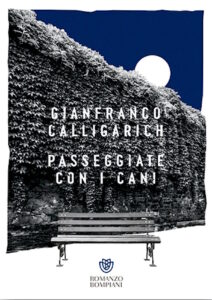
È uno scrittore e lo scrittore Gianfranco Calligarich, adoperando la terza persona, sa fargli volgere uno sguardo terso sul passato, e ripulire il racconto dalle scorie (anche linguistiche) del presente, scrivendo in modo piano lunghe frasi sporcate da un minimo di punteggiatura. I personaggi rievocati, uomini, donne e bestie, sono descritti nella semplicità dei gesti e dei sentimenti, in una stilizzazione che può volgersi a una simbolica indeterminatezza poetica o diventare solenne, approdare a una laica religiosità della vita – in fondo, il vecchio ha sempre pronta per sé e per i suoi animali l’ostia di “un pezzo di pane bianco senza sale”. In fondo, cioè al principio, Calligarich ha posto in esergo una frase di Hemingway sulla trasmissibilità dell’esperienza (da Morte nel pomeriggio).
Comunque. I personaggi di Passeggiate con i cani (Bompiani) non si dimenticano, per esempio il lupo Martin Eden, assoldato tra gli umani, o il giornalista comunista Bracaglia, poiché hanno “grandi e solitari cuori” o, da morti, come una celebre scrittrice, mostrano il viso di chi ha pagato “lo scotto di essere stato vivo”.
Un espediente per raggiungere una sorta di incanto nel racconto è volgersi a cose e azioni come fossero viste e tentate per la prima volta, così come accade con l’arrivo in una Roma “immensa e intimorente” dove l’uomo sbarca da giovane con la speranza di lavorare nei giornali.
È quasi automatico attribuire al protagonista del libro qualcosa di Calligarich stesso – ritrovare in queste cento pagine quel coefficiente di autobiografia che, da L’ultima estate in città a La malinconia dei Crusich (entrambi editi Bompiani), è un marchio di stile e di sincerità, qui a tratti disarmante.
Di Calligarich abbiamo già parlato qui





