Molto tempo fa, quando lavoravo in un settimanale popolare, mi capitava di “passare” una rubrica di recensioni librarie affidata ad Arturo Tofanelli. Essendo io giovane e ignorante, ignoravo chi fosse il vegliardo – che avesse i suoi begli anni, s’intuiva, poiché inviava testi lunghissimi e illeggibili, scritti a macchina ma corretti a mano con quella calligrafia tremula dei vecchi che avrebbe dovuto commuovermi invece di irritarmi. Breve: Tofanelli, all’ultima spiaggia della sua leggendaria avventura professionale, rappresentava per me una scocciatura. Andava tradotto nei punti dove sorgevano dubbi di comprensione e brutalmente tagliato per metterlo in misura, per cui i testi, già esoterici in partenza, diventavano ancora più oscuri al punto che mi sembrava contenessero messaggi cifrati. Uno di questi poteva riguardare la fine della mia carriera giornalistica: infatti, come scoprii, Tofanelli era zio del direttore del periodico, e una volta, solo una volta per fortuna, e questo lo reputo un miracolo o un segno della sua generosità, Tofanelli si lamentò di me…
Ho incominciato con un ricordo perché sto parlando di un’altra epoca. Di giornalismo dei tempi d’oro, da me intravisto solo al cannocchiale o al telescopio. Trovo il nome del non dimenticato Arturo Tofanelli – oggi so chi è, i giovani guardino su Wiki – al timone di un mensile ambizioso, Successo, che ospitò dal 1959 grandi firme della stampa e tra queste una nuova stella, Gian Carlo Fusco (1915-1984), spezzino di stanza a Milano dopo traversie francesi, che era stato consacrato eclettico notista di costume da La colonna di Fusco presente fin dal primo numero sul Giorno di Baldacci (21 aprile 1956).
Il titolo della rubrica di varia umanità che Fusco inaugurò su Successo, Arpa e cannone, dovrebbe indicarne il contenuto, ma è in qualche modo sviante. Secondo Dario Biagi, massimo interprete fuschiano e curatore del graditissimo volume Arpa e cannone. La pagina più scintillante del mensile “Successo” (1959-1963), Aragno editore, Fusco non arriva mai letteralmente all’arpeggio e, quando colpisce, lo fa di fioretto e sempre mantenendo un brandello di quella pietas che per esempio manca a un Flaiano.
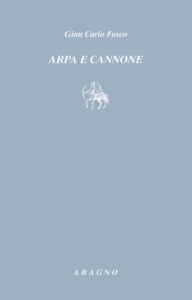
Comunque. In Arpa e cannone, che contiene tutti gli scritti apparsi sul mensile, campeggia un Fusco scatenato, unbound, fresco com’è pure del successo librario de Le rose del ventennio (prima edizione ne I Coralli Einaudi, poi Rizzoli e ora Sellerio). Occupandosi di tutto nella sua esistenza randagia e nottambula, di tutto può scrivere: mondanità e cultura, nightclub e mercati di frutta, cinema e tv, boxe e teatro, dive di Hollywood e gente en travesti, che sia parigina o nostrana non importa – Parigi è il faro chic per la borghesia milanese che Fusco sfotte esibendo il sorriso sarcastico della sua celebre dentiera, cui sono legati infiniti aneddoti.
Ogni mondo che Gian Carlo Fusco affronta o a cui dedica una serie di pezzi che raccoglierà poi in volume, malavita compresa, lo vede al minimo co-protagonista. Ancor più adesso che gli anni di Successo ratificano l’ampliamento dei suoi interessi – per esempio il teatro, in combutta con l’amico Cobelli – e preludono al trasferimento da Milano (dalla casa vicina al bar di via Ampère 15) a Roma. Roma significa cinema, cui Fusco presterà con risultati alterni la sua verve affabulatoria – per sbarcare il lunario sceneggerà (pare) persino dei peplum.
Ma posso confessarlo? Il gran pregio del libro che ho tra le mani, servito da una prefazione essenziale e utilissima a buttarci storicamente in medias res, è il divertimento puro che provoca leggere questa mitragliata di testi.
Brevi e puntuti, umorali e umoristici, finto cinici e sentimentali e forse finto sentimentali, risolti di volta in volta in forma di elzeviro, di chiacchiera informata, di dialogo da treno o addirittura di sketch, di micro racconto e persino di ricordo di scuola: ecco, questi articoli compongono una sorta di survoltato e ispirato ritratto dell’Italia del Novecento (non solo di quella del boom), dipinto a velocità supersonica e con impareggiabile estro da un italo Balzac alcolizzato che, in fatto di agudezas, può battere sia i vecchi professionisti dell’aforisma sia l’avant-garde alla Arbasino – tra parentesi, chiunque possedesse il codice per decifrare il funambolico pezzo ferroviario del Pope peloso che legge Carlo Coccioli mi scriva (e pazienza se è politicamente scorretto).

Ma fermiamoci un attimo. Mi sembra che il bersaglio della mobilissima prosa di Fusco – e questo rende maggiore, filtrandolo d’amaro, il divertimento – sia l’immenso luogo comune che chiamiamo realtà, il luogo comune che imprigiona noi miseri mortali in ruoli e cliché e che Fusco documenta da cronista avventuroso fino alla panzana grazie alla sua vocazione di libero narratore.
Scrive Dario Biagi nell’introduzione che Fusco si affida spesso ai ricordi e, aggiungo io, si fida di loro: è il suo modo di ribadire, nonostante il passare del tempo e il mutare delle mode, “la continuità e l’inalterabilità dei nostri vizi e delle nostre virtù”, il nostro trasformismo e il nostro gattopardismo. Fusco sarebbe infatti un “vitalista disincantato, un viveur leopardiano” nel suo modo di prender la vita così come viene e come va, e nel raccontarla senza tromboneggiare, esibendo a volte la saggezza dell’accettazione.
Tra i luoghi comuni ce n’è uno correggibile riguardante una certa immagine di Fusco, il personaggio Fusco diventato mitologico e usato a mo’ di clava da chi ripete martellante che “il giornalismo non è più quello d’una volta”. È vero, e non solo per i rimborsi spese, nel caso di Fusco assolutamente ribaldi. Forse però è più corretto lamentarsi del fatto che sono pochi i giornalisti d’oggi in grado anche solo di allacciare gli scarpini da boxeur di Gian Carlo Fusco: stiamo infatti parlando di un vero scrittore – potrebbero bastare per reputarlo tale Duri a Marsiglia (Einaudi) o A Roma con Bubù (Sellerio), pur se Biagi lo trova fiacco – o, se preferite, di un irripetibile artista della parola.
Nel dargli le coordinate letterarie che gli spettano, ha merito appunto Biagi (che Fusco non possedesse la vanità dello scrittore non significa che non ne avesse il valore): la sua biografia dello spezzino, L’incantatore. Storia di Gian Carlo Fusco (Avagliano), contiene un’accurata disamina dei testi maggiori ed è stato il primo atto di un impegno che, con la riproposta di inediti carteggi, arriva fino a ora.

Chiudiamo omaggiando il Fusco di Arpa e cannone, pescando nel mucchio di tanta ricchezza. Trovo esilarante il testo sui giovani che non sanno più morire come una volta: è il parere di un generale e di un ammiraglio, che chiacchierano al bar bonari come due boia. Oppure – funziona ancora benissimo – la sghignazzata riservata all’Italia del Fascismo e di rimbalzo a un ipocrita Montanelli, in un ritratto sui ventenni dell’MSI che sognano di ripetere le gesta da baraccone del Ventennio. Sull’altro fronte, fa pensare La rivoluzione può attendere: “Mesi or sono, riuniti in assemblea a Roma, i più distinti intellettuali del Pci riesaminarono le loro posizioni. Fecero critica e autocritica. L’autocritica della critica e la critica dell’autocritica…”. Sono andato non so perché sul politico – sarà il periodo – ma aggiungo due altri pezzi da hit parade. La risata di Ekberg che è un breve racconto in sé concluso: nasce sull’aerea Terrazza Martini per la presentazione della Dolce Vita, e viene risolto in modo imprevedibile da una proustiana e brutale intromissione del cuore. E I cani, questi viceuomini perché è uno dei pezzi più geniali e pessimisti di tutta la raccolta (poveri uomini, poveri cani). Buona lettura.
Di Dario Biagi giornalista e scrittore abbiano parlato qui





