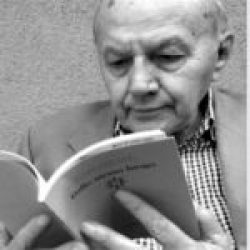Il cavallo un certo giorno (il terzo) smette di mangiare e poi non vuole più bere. L’esistenza del vecchio cocchiere dal braccio morto e della ragazza silenziosa, che avevano nel cavallo l’unico alleato o schiavo, va ancor più controvento – qui, nella campagna deserta, il vento soffia sempre, selvaggio e minaccioso, “bucando” la pellicola con foglie e sterpi svolazzanti, quasi fossero simboliche imperfezioni della vulnerabile materia su cui è riprodotta la storia. Una storia di sei giorni (quasi) uguali.
Ebbene, di fronte alla resa del cavallo che cessa di obbedire all’elementare legge di sopravvivenza, anche la vita dei due umani subisce l’immiserimento di chi si vede condannato, oltre che a una stremante e improduttiva routine in una terra (una Terra?) di nessuno, all’estinzione.
Nella campagna in qualche modo antica, che potrebbe essere ottocentesca (ma chissà quanto pre capitalistica) o suggestivamente medievale o addirittura eludente il tempo – la campagna presagio di un inospitale oltremondo o di un suo anteporta – tutto si avvia pesantemente verso la morte.

Nei sei giorni del racconto – manca appunto il settimo, significativamente quello del riposo in una Genesi ribaltata – seguiamo il vecchio padre e l’obbediente figlia, invitata dal genitore a compiere azioni elementari. Ma la ragazza è davvero la figlia e non, forse più semplicemente, un altro animale da fatica?
Nei sei giorni siamo contagiati anche noi spettatori dal tedio dei gesti ripetuti, così come il tedio attanaglia e influenza forse maliziosamente lo sguardo e i movimenti della macchina da presa di Béla Tarr.
Talvolta pare quasi di avvertire una calcolata perdita di tensione nei lunghi e abituali piani sequenza e una rinuncia a seguire, lasciandoli per una volta lontani, i personaggi, mentre al contrario nell’indimenticabile incipit del film il vecchio cocchiere e il cavallo in fuga dalla città sono braccati sì, ma quasi aiutati e incoraggiati dall’occhio e dal movimento della camera. Invece, ora li vediamo distanti, il padre e la figlia, magari nel momento in cui guardano – che cosa? Il niente – fuori da una piccola finestra. Quella finestra è il loro cinema?
Tra l’altro: sapere che il film è composto di una trentina di piani sequenza per una durata totale di due ore e quarantasei minuti significa che vediamo (dal nostro cinema finestra) quasi ogni gesto nella lentezza del tempo reale così come, amplificandola, ce la restituisce il grande schermo.
Il tema di A torinói ló-Il cavallo di Torino (2011) è la fine dell’umanità, della divinità – se non è già morta o mai esistita, assassinata da chi ha saputo troppo, vedi l’aforisma celeberrimo de La gaia scienza -, la fine di un’idea rivoluzionaria di cinema. O almeno: del cinema che protegge o che può restituire la dignità all’uomo – Tarr dixit: tutta la sua opera pone al centro la dignità dell’uomo e la solitudine, come gli ha insegnato pure una versione del Macbeth, è la condizione esistenziale dei suoi eroi, che nella società in cui vivono sono outsider o emarginati.
Il cineasta ungherese con A torinói ló smette da (quasi) giovane di girare (è nato nel 1955), per conclusione di un percorso e di un discorso, o piuttosto per la stanchezza di finire in scacco. Non segna Il cavallo di Torino l’evidente impotenza del mezzo a cambiare la realtà? L’immaginazione di Tarr, per quanto apportatrice di meravigliose variazioni, non termina con lo sbattere contro l’universo chiuso, sigillato, dello stesso set, contro la finzione da lui stesso architettata in sintonia con la crew, come se fosse una mosca che si trova a zampettare o a sbattere contro il limite concreto della lente dell’obiettivo? Così accade a un moscerino, in un frame che ho rivisto per caso in rete, nell’aria di tempesta che minaccia la campagna, questa sì nient’affatto metafisica ma storicamente definita, del capolavoro di Tarr Sátántangó (1994).
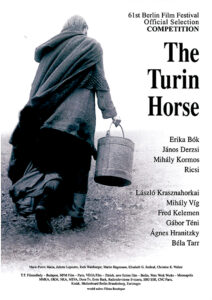
Ma riavvolgiamo la pellicola di A torinói ló. Il film parte dal racconto in voice over di un episodio della vita di Friedrich Nietzsche: prima di scomparire per sempre nella follia, nel 1889 il filosofo bacia commosso un cavallo da stanga a Torino, e forse il cavallo e il vecchio che vediamo subito dopo, nella poderosa e “spettinata” sequenza iniziale, sono gli altri due personaggi della leggendaria vicenda – ma il resto del film non può essere forse, o anche, una messa in scena, metonimica, della pazzia del pensatore tedesco?
Girato in un bianco e nero d’altri e di sicuro migliori tempi, volontariamente emulo dei film del muto, e servito – altro che musica per il principe Vogelfrei! – dalla ripetizione ottundente di una frase d’archi la quale s’intona al vento indifferente alla sorte degli uomini, Il cavallo di Torino sembra portarci in un presente che contempla un “eterno ritorno” nietzchiano, un “pensiero abissale”, sia in piccolo scorcio quotidiano sia in imponente prospettiva d’Apocalisse.
Il ripetersi delle giornate è interrotto da visitatori diversi che rompono la monotonia della vita di padre e figlia. Un ospite parla del cupo destino che tocca agli uomini senza dio, dice: “…d’un tratto si resero conto che non ci sono né dio né dei. D’un tratto videro che non esiste né bene né male. Poi videro e compresero che se così era, allora nemmeno loro stessi esistevano!…”.
Ecco un espediente formale amato se non da Tarr dall’illustre cosceneggiatore, lo scrittore László Krasznahorkai, che ne ha tratto capitoli indimenticabili nei suoi romanzi: consiste nell’offrire lunghi discorsi di verità e disgrazia, filosofici o messianici, sempre virtuosisticamente oscuri, discorsi che si insinuano allarmanti nel resto della partitura – in questo caso il prolisso avvertimento cade pressapoco nel silenzio, poiché il resto della pellicola è quasi muto. Per rimanere all’opera condivisa da Krasznahorkai con Tarr, si pensi allo spettacolare discorso sull’eclissi di sole del fattorino Valuska nella taverna di Werckmeister harmóniák, tratto da Melanconia della resistenza (molto di Krasznahorkai in anni recenti è stato edito da Bompiani).

Seconda visita. Irrompe in scena una compagnia di zingari, tra cui si nasconde o, per dire meglio, si presenta a viso aperto, l’intera troupe del film, a partire da Tarr e Krasznahorkai – ammettono così di essere incapaci di abbandonare la finzione? Tra le mani della figlia, finisce una sorta di Bibbia – anche l’esistenza di libri o testi sapienziali è un’ossessione prima che un topos dello scrittore ungherese. Mentre prova faticosamente a leggere – nella sua vita ogni gesto è grande fatica – la ragazza si rivela semi analfabeta, a riprova che tutto il mondo del Cavallo di Torino soffre di un handicap, di una menomazione, di una mancanza.
Muoversi, andarsene, sembra a un certo momento una via ancora percorribile, e invece si tramuta in un altro esercizio inutile e azzerante, si risolve nel tornare indietro ripetendo tutti i gesti della partenza ma all’inverso (un altro tipo beffardo di “ritorno”) – era troppo debole la ragazza per tirare lei il carro cui si è accodato il cavallo in un altro rivolgimento speculare d’immagine rispetto alla normalità, era troppo forte la natura avversa.
Il posarsi improvviso del vento non sarà un segno fausto mentre a nessun ordine del padre prepotente o per lo meno assertivo può ormai essere legata una chance di vita vera, non vegetale – dire “vita animale” è già uno sproposito. Chissà se è avanzata una patata lessa da scartocciare con una mano sola…

Con questa opera, firmata alla regia insieme alla fedele montatrice Ágnes Hranitzky, Béla Tarr ha detto stop a ogni speranza per il mondo e per il suo cinema. Lo afferma nel noto massimalismo generoso e sentimentale, ignaro della strizzata d’occhio da “ultimo uomo” nietzchiano ma forse non della scaltrezza connaturata all’artista post moderno, che ha finito per stancarsi dei suoi stessi giochi di prestigio – è paradossalmente questa abilità anche il limite, a tratti invalicabile, di Krasznahorkai scrittore. Ma Tarr al suo meglio può essere quasi tutto e può dire quasi tutto. O una parte notevole del quasi tutto: potremmo anche deciderci, una volta e via, di prenderlo per un “moderno”, ultimo o primo degli ultimi grandi.
Sorprende notare l’evoluzione del cineasta ungherese, partito con film da macchina in spalla che lo avevano fatto paragonare a John Cassavetes (!). Filosofo mancato per opposizione del regime e uomo di spettacolo per eredità di famiglia – ma Tarr è e resta un filosofo seppure sui generis non foss’altro perché in A torinói ló decreta la fine del suo lavoro accostandolo al crollo di Nietzsche che smette di pensare – Tarr, dicevamo, ha inaugurato a fine anni Settanta un periodo di “cinema sociale”, volto al quotidiano. Debutta con verve proletaria senza budget e copione, con attori dilettanti e la regola di stare fuori dalle regole.
In questi giorni, ho ripescato Szabadgyalog (L’outsider) del 1980, che si apre in un manicomio: nel protagonista, un infermiere violinista, anarchico e ubriaco, colgo un parente degli straccioni beckettiani, delle anime morte gogoliane o dei rovinati intellettuali dostoevskiani che animeranno la seconda vita cinematografica dell’ungherese – i suoi “nuovi” outsider non perderanno niente in verità ma acquisteranno in spessore. È del 1985, invece, Őszi almanach (Almanacco d’autunno), il film girato in un appartamento che segna lo spartiacque tra le opere d’esordio – camera a mano e primi piani – e la maturità dei piani sequenza di Kárhozat (Perdizione), del 1988, prima opera in collaborazione con Krasznahorkai. Siamo solo a un passo dalle sette ore e mezzo del capolavoro Sátántangó…
Intanto. Si può vedere (ammirare) A torinói ló su YouTube, ed è una sorta di beffa, poiché l’unico schermo per cui è costruito è quello cinematografico – poi chiacchieriamo pure, a fronte dello straordinario genio visivo di Tarr, di Nanni Moretti che odia Netflix e di altre fregnacce… Del resto, molti film di Tarr, a ben cercare, si trovano su Internet, naturalmente in copie usurate e al di fuori dei cc: si tratta di edizioni complete in varie lingue oppure di trailer e di frammenti di pellicola rubati qua e là a un titolo o all’altro, i quali rilanciano beffardamente questi capi d’opera triturati dal nemico web ma ancora – come sequenze pirata giunte da un’altra galassia – vivide e strabilianti nella forma e nei messaggi.
Sul fatto che l’intero film sia una metafora del fare cinema, si legga sullo Specchio Scuro lo studio di Nicolò Vigna. Dei romanzi di László Krasznahorkai Allonsanfàn si è già occupato qui.
Nella foto d’apertura, Béla Tarr (Credit: Béla Tarr Bela Tarr by V31S70 is licensed under CC BY 2.0.)