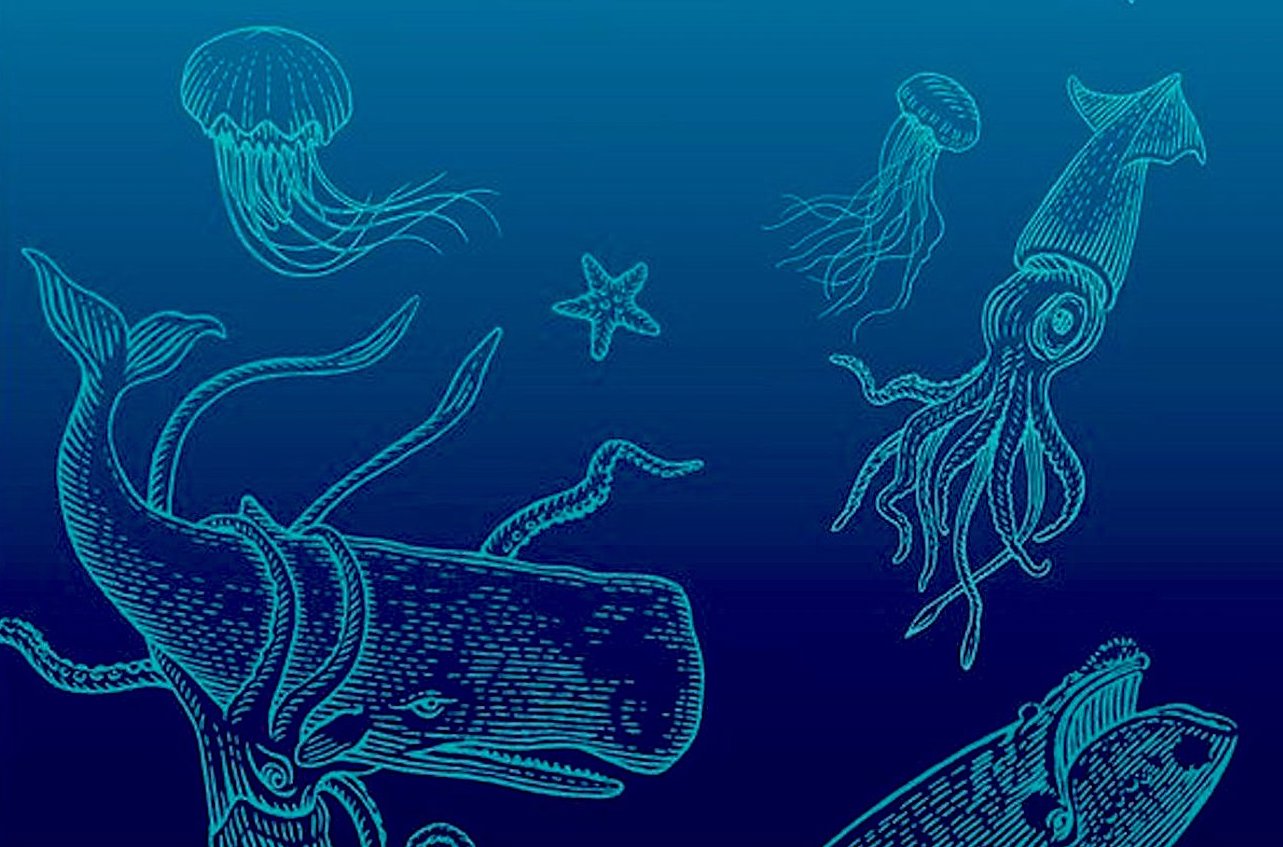Vista dallo spazio, la Terra è un’incantevole biglia blu, appesa al buio dell’universo come la più bella palla di Natale. A darle quel colore, unico (per quanto ne sappiamo) nell’infinito catalogo delle meraviglie cosmiche, è l’acqua di cui è composta per oltre il 70 per cento. Quasi tutto è mare, quasi tutto è oceano. E a questa sterminata e inafferrabile distesa è dedicato uno dei più affascinanti saggi scientifici in circolazione: L’uomo con lo scandaglio dello svedese Patrik Svensson, edito da Iperborea.
Una ballata di 222 pagine in cui la storia del mare è la storia di come noi umani, incoscienti, predatori, spinti da un misto di presunzione, coraggio e opportunismo, lo abbiamo esplorato, solcato, conquistato, sfruttato. E dal quale siamo stati tante volte sconfitti: viaggi spericolati finiti alla deriva, tragici naufragi, battaglie navali nelle quali le sue acque si sono riempite di sangue e di corpi, tempeste perfette, lotte con squali e balene che – un tempo – capovolgevano le imbarcazioni che davano loro la caccia (come nel duello infinito tra Achab e il capodoglio Moby Dick).

Ogni capitolo fa da sé, è un portale che, una volta attraversato, ci porta in luoghi ed epoche osservati come da una capsula del tempo, al riparo dagli sconvolgimenti raccontati, godendo delle magnifiche imprese, affascinati dalle scoperte su, come cantava Lucio Dalla, quanto è profondo il mare, quante specie aliene nasconde. Abissi da perderci la ragione, a malapena conosciuti se è vero che sappiamo assai di più sui paesaggi lunari e persino marziani rispetto a quelli nascosti sotto le onde, dove la luce non penetra mai e tutto è silenzio.
L’uomo con lo scandaglio che dà il titolo al libro è colui che affronta l’ignoto e sposta i confini, perché l’idea di non sapere è intollerabile. E «andare a vedere» irresistibile provocazione. Sono i primi navigatori, gli antenati dei Polinesiani che, più di 5 mila anni fa, navigarono per immensi tratti di oceano senza strumenti per stabilire la rotta in quell’immensità acquatica, e però riuscirono a sbarcare su grandi isole fino ad allora disabitate. È il portoghese Magellano, che si imbarcò a 20 anni, spinto da una visione colonialista del mondo, nel corso dei suoi viaggi si comprò uno schiavo di Malacca, visse alterne fortune su innumerevoli mari, servì il Portogallo e poi la rivale Spagna e morì massacrato su una spiaggia dopo aver dato alla Terra un’altra dimensione.

Uomini con lo scandaglio erano i primi balenieri, che ispirarono gli inseguimenti folli al Leviatano bianco («la più formidabile a sfidarsi di tutte le balene» scrive Ismaele, il narratore del romanzo di Melville), maestoso abitatore marino che porta Achab alla follia e alla morte.
Fu a modo suo un grandissimo esploratore (anche se il suo nome dice poco alla maggior parte di noi), il panettiere scozzese Robert Dick, nato nel 1811, una vita sottotraccia quasi commovente nella sua tenacia di sapere, e imparare, e stupirsi di fronte agli innumerevoli tesori del Creato.
Ci inchiniamo, dopo aver letto il capitolo a lui dedicato, alla passione che lo portò per quasi tutta l’esistenza, dopo aver finito di faticare nella sua bottega del pane a Thurso, ventosa cittadina delle Highlands scozzesi, a macinare chilometri a piedi, per ore e ore, lungo la baia e nella brughiera, cercando fossili di pesci, conchiglie, pietre, farfalle, piante e fiori. Senza famiglia, né amori, né figli, senza una vera vita privata, estraneo a qualsiasi consesso accademico, e con davvero pochi soldi, riuscì a vivere con un amore per la natura e un’intensità di emozioni di fronte a cui le nostre comode esistenze paiono un cortometraggio dai colori un po’ sbiaditi.
Lui, Robert Dick, fu un gigante. Capace di uscire nel cuore della notte solo per vedere un fiore particolare aprirsi all’alba; di percorrere 20 chilometri per cercare alcune piante che crescevano vicino a un fiume. Trascorse i suoi anni camminando, osservando, raccogliendo, studiando, catalogando, collezionando. Alla fine qualcosa di unico, nel 1863, lo scoprì davvero: un particolare fossile di pesce primitivo, il primo essere del pianeta che, nel corso dell’evoluzione, iniziò a riprodursi per via sessuale e non per partenogenesi. Per la scienza, una piccola rivoluzione. Lo chiamarono – ma lui morì prima di saperlo – Microbachius dicki.

La visione del mare, orizzonte immenso e potente, fu l’incontro della vita anche per Rachel Carlsson (oggi la ricordiamo soprattutto per il saggio Primavera silenziosa contro i pesticidi), che ne divenne la biografa più famosa al mondo: Il mare intorno a noi era un inno d’amore, sia pure scientifico in ogni dettaglio, a quell’universo liquido da cui ebbe origine ogni forma di esistenza sul pianeta. «Entriamo in un mondo antico come le stesse terre emerse» scriveva «il luogo primordiale dell’incontro fra gli elementi della terra e dell’acqua, un luogo di conflitto ed eterno mutamento». E ancora: «Lo spirito del mare è una forza implacabile, spietata, grazie alla quale tutto attrae a sé, grazie alla quale sopraffà, divora e annienta. I fiumi vi ritornano, le piogge che da esso nacquero vi fanno ritorno».
Fu anche lei, fra i tanti, «l’uomo con lo scandaglio», che indaga, esplora, si immerge, si smarrisce nella visione delle meraviglie marine. Ma il desiderio di dissiparne l’aura di mistero non fu mai il suo obiettivo, anzi. «Dubito che possano essere risolti gli ultimi e fondamentali enigmi legati al mare. In realtà nutro una speranza decisamente non scientifica che non vengano sciolti mai».
E noi, in fondo, la pensiamo come lei. Del resto, ben difficilmente riusciremo a scoprire davvero cosa si cela là sotto, ed è una fortuna. Non per timore di chissà quali mostri marini, come nelle ingenue mappe del passato pieni di draghi e spaventosi calamari giganti, ma semplicemente perché il mistero degli oceani è bello che resti tale, e i suoi abissi non vengano troppo illuminati dalla nostra abbagliante e molesta curiosità.
- Alice Caroli è una giornalista torinese