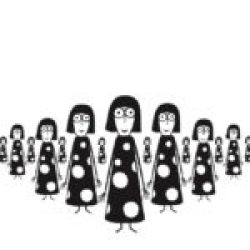Qual è il gioco di prestigio più difficile al cinema? Semplice: raccontare in un film il giorno della marmotta, cioè le giornate sempre uguali – se siamo fortunati, se va tutto bene – della nostra vita, la qual cosa senza stecchire di noia il pubblico pagante.
Wim Wenders, 78enne maestro del fu Junger Deutscher Film, in Perfect Days sceglie di partire lento, percorrendo con pedanteria e minimi cambiamenti la quotidianità di Hirayama, maturo toilet man (pulisci cessi) di Tokyo, da mane a sera notte compresa.

Hirayama si sveglia, arrotola il materasso, prende il caffè dal distributore nel cortile della sua baracca, parte su un pulmino dopo aver scelto la musica tra vecchie cassette (ah ecco, è un uomo analogico!), si reca ai gabinetti pubblici, che netta con una costanza per la quale noi banali occidentali pensiamo subito che il toilet man sia una sorta di monaco zen, e poi, sempre muto o con un sorriso appena accennato, quasi da personaggio chapliniano, si lava ai bagni in comune e mangia nel locale di una signora capace all’occorrenza di cantare il blues (la drammatica House of the Rising Sun), non senza aver aver sopportato il suo partner in pulizie, controllato quel che fa uno svanito homeless e scattato qualche foto agli alberi con una vetusta macchinetta (è un uomo analogico!); quindi, a Hirayama non resta che passare in biblioteca, leggere un po’ di Faulkner (ah, ecco non è un ignorante!), e riguadagnare il sonno. I sogni dell’uomo sono resi da immagini fantasmatiche in bianco e nero da compassato film surrealista.
La giornata del toilet man – dimenticavo: Hirayama lo ha scritto sulla schiena come una funzione o una specifica del suo essere – si ripete pressapoco uguale sullo schermo come nello spartito di un compositore minimalista (Philip Glass, Terry Riley…), nonostante la soundtrack scelta per il pulmino sia rock anni Settanta – il titolo del film ricalca il “just a perfect day” di Lou Reed che, secondo la vulgata, è la giornata morbida e al ralenti di un eroinomane, questo per dire che Wenders sparge tracce di una possibile inquietudine… Comunque: saranno proprio le variazioni della partitura, vieppiù consistenti, a scavare una storia nel flusso eguale dei giorni, a raccontarci (lasciar intravedere) la storia dell’uomo – ma c’è?, sì c’è, un po’ come c’è per tutti, ma per Hirayama di più perché siamo pur sempre in un film – e la conosciamo nel mentre che incominciamo a sbuffare e a pensare che il toilet man sia una sorta di idiot savant, a onta di Faulkner, o di eterno fanciullo, e che il regista tedesco, non ispirato, stia facendo un mero esercizio di stile.

Saranno gli altri – una ragazzina, per esempio, la nipotina che gli capita tra capo e collo – a stanare il passato o a calpestare, fermandola per un attimo, l’ombra di Hirayama per terra… Una ragazzina, ci torna in mente, come la bambina di Alice nelle città, che svelò a se stessi Rüdiger Vogler, e Wenders, tanti anni fa (era il 1973 e, seri com’eravamo, trovammo il tutto un po’ sdolcinato).
Ma poi: Perfect Days è un film di Wim Wenders? C’entra qualcosa, oltre che con il docu Ozu-dipendente Tokyo-Ga (1985), con i titoli del passato del regista tedesco? In fondo, Perfect Days è un viaggio (interiore) di un regista notoriamente viaggiatore, qui alla ricerca, se non di un senso o della bellezza delle piccole cose (due cliché sempre buoni), di un’esistenza tollerabile… Ma non so rispondere bene, non ho più memoria della cosiddetta trilogia della strada o de L’amico americano, non ricordo bene neanche che cosa è successo im Lauf der Zeit, cioè nel corso del tempo, a tutti noi che a Milano andavamo all’Obraz Cinestudio, esaltando pure le illeggibili sperimentazioni dell’un tempo sodale wendersiano Peter Handke. Wim l’avvocato mancato, più degli altri tedeschi, assai folli e rigorosi e – credo che c’entri – all’apparenza molto meno americani, Wim era un adorabile fratello maggiore. Forse vale la pena rivederlo da capo, ripescando su YouTube quel Summer in the City (1970) che ne segnò il debutto nel lungometraggio registrando la quotidianità spicciola (la realtà) di un uomo di ritorno dal carcere e chiamato a un misterioso appuntamento…
Intanto, il vangelo Wiki ci consegna la risposta alla domanda precedente (Wenders è sempre Wenders?) come un juke box che impiatta la canzone giusta (nel caso, una dei Kinks, presenti sia nel primo sia nell’ultimo film). Ecco lo specchietto, che ne desumo, di alcuni temi essenziali del regista tedesco: i luoghi e gli spazi urbani sono protagonisti – la città, le strade, gli edifici, i marciapiedi, le insegne, i negozi, i bar, i flipper, i distributori di sigarette. Il disagio esistenziale si manifesta in azioni minime, di sovente interrotte, e in un acuto senso di spaesamento. Il ritorno del passato diventa la difficile fuga da demoni invisibili. La solitudine e la difficoltà di comunicare, alla fine, presentano il conto…
Comunque. Oggi, il linguaggio formale di Wenders mi sembra improntato a un equilibrio fin troppo giudizioso, riscattato però – il genio sonnecchiava soltanto – da un’inquadratura finale in primo piano, quasi interminabile per l’emozione che esprime, sul volto di Hirayama. Vale l’intera pellicola (il film sarà girato su pellicola, no?) e riscatta la mia partecipe noia: intanto è valsa a lui, l’attore Kôji Yakusho, il premio sacrosanto di miglior attore a Cannes 2023. Per dire, guardando l’ultima lunga inquadratura si può anche commuoversi e uscire dal cinema tirando su col naso.