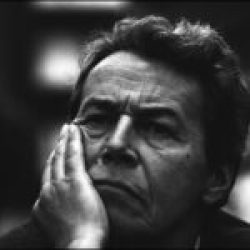Le ombre degli avi dimenticati, girato nel 1964, restaurato grazie alla Film Foundation’s World Cinema Project di Martin Scorsese, al Dovzhenko Film Studio di Kiev e alla Cineteca di Bologna – dove è stato presentato al recente Festival del Cinema Ritrovato – è un film di rapinosa bellezza. Come lo sono, ciascuno a suo modo, tutti i film di Sergej Paradžanov, sequenze di immagini “impressioniste” sontuosamente essenziali, e di suoni primordiali (più suoni che parole) prodotti a volte da strumenti musicali arcaici anche molto pittoreschi come quei lunghi corni di legno – si chiamano trembite e raggiungono gli otto metri di lunghezza – che nei villaggi carpazi dell’antica popolazione Hutsuli scandiscono gli eventi allo stesso modo delle campane nelle nostre chiese.
E sempre ci cattura e stupisce, Paradžanov, con l’attenzione ai dettagli, agli oggetti, a ciò che senza dire dicono: come il giogo al collo dei due sposi nella locandina del film, messo lì, quel giogo da buoi, a significare qualcosa (interrogato al proposito, il regista spiegò che quello non era un matrimonio d’amore – la ragazza che lo sposo amava davvero era morta scivolando nel fiume -, ma imposto dagli obblighi sociali).

Nato da genitori armeni a Tbilisi in Georgia nel 1924 e vissuto a Kiev, il regista Paradžanov è stato un innovatore dei canoni stilistici appresi alla scuola di cinema Vgik di Mosca e poi da lui genialmente e pericolosamente disattesi nella pratica del suo lavoro al Dovzhenko Film Studio di Kiev, la città che al suo tempo, quando l’Ucraina ancora faceva parte dell’unione, era detta “la capitale sovietica del Cinema del sud” (rispetto alle “nordiche” Mosca e Leningrado).
Il primo a proclamare che il film Le ombre degli avi dimenticati era “un capolavoro!!!” fu nel 1965 il critico Mario Verdone (padre di Carlo) al Festival di Mar del Plata dove la giuria da lui presieduta gli assegnò il premio Migliore Regia per essere allo stesso tempo “finzione e documentario, tradizioni shakespeariane occidentali, slave, orientali, tutte insieme, con un colore smagliante quasi divisionista, una fotografia ‘alla Visconti’ e la musica, canti popolari perfettamente ricreati”. Dopodiché il film, osannato dalla critica con un clamoroso successo internazionale, veniva al contempo vietato in patria come esempio di “degenerato cinema poetico”, “misticismo borghese”, e il regista accusato di omosessualità, spedito in un centro di “rieducazione”: la prima delle fantasiose accuse – dalla diffusione di malattie veneree all’istigazione al suicidio – che hanno condannato Paradžanov ad anni di carcere duro (verrà liberato grazie a una petizione internazionale promossa dal surrealista André Breton), causandogli comunque la malattia ai polmoni per la quale morirà nel 1990.
Tratto dall’omonimo breve romanzo di Mychajlo Kocjubyns’kyj (1864-1913) il film si svolge in un paese dei Carpazi, dove il regista visse, durante le riprese, non in una locanda o in un albergo, ma insieme a gente del posto nella casa, set del film, che è poi diventata “il museo” del film stesso, oggi pietra miliare, come il libro, della cultura ucraina. La trama è semplice, amore e morte tra un giovane Ivan e una giovane Marichka, appartenenti a due famiglie divise da antico odio, insomma una storia vecchia almeno quanto Shakespeare. Ma non è questo che conta: a rendere il cinema di Paradžanov assolutamente originale, è che “è come aprire una porta e camminare in un’altra dimensione, dove il tempo si è fermato e la bellezza è stata liberata”, come ha detto Scorsese de Il colore del melograno girato nel ’68 (il film per Michelangelo Antonioni “è di una bellezza perfetta e Paradžanov uno dei migliori registi al mondo”).

L’ho visto su Prime Video Il colore del melograno (si trova anche su Youtube): completamente diverso da Le ombre. Uguale a nessun altro film. Bellissimo. È La vita del poeta armeno Sayat-Nova raccontata dall’infanzia alla morte con una successione di scene che sono pantomime, tableaux vivants senza parole: solo alcune didascalie corrono di tanto in tanto sotto le immagini ripetendo alcuni versi del poeta. In una delle didascalie è scritto: “Noi cercavamo un rifugio per il nostro amore ma il cammino ci ha condotto nel mondo dei mortali”.
Ed è tutto, che altro dire. Poi però. Poi però mi viene in mente la direttrice del Dovženko FilmCenter di Kiev, Olena Houchanuk, presente al Festival di Bologna: ha raccontato che, nella Kiev di oggi disastrata dalla guerra, tra innumerevoli difficoltà, c’è tuttavia chi ancora si occupa di salvaguardare, restaurare, digitalizzare, il materiale, circa novemila tra film e documentari conservati nel Museo. E allora viene da pensare che un rifugio qualche volta c’è, anche in questa terra di mortali.
Nella foto grande, il regista. Le immagini arrivano, cortesemente, dalla Cineteca di Bologna
- Jonne Bertola, giornalista milanese. Autrice del romanzo Swinging Giulia, di Piacenza (Morellini) e di Di chi è questo corpo (Luoghinteriori)