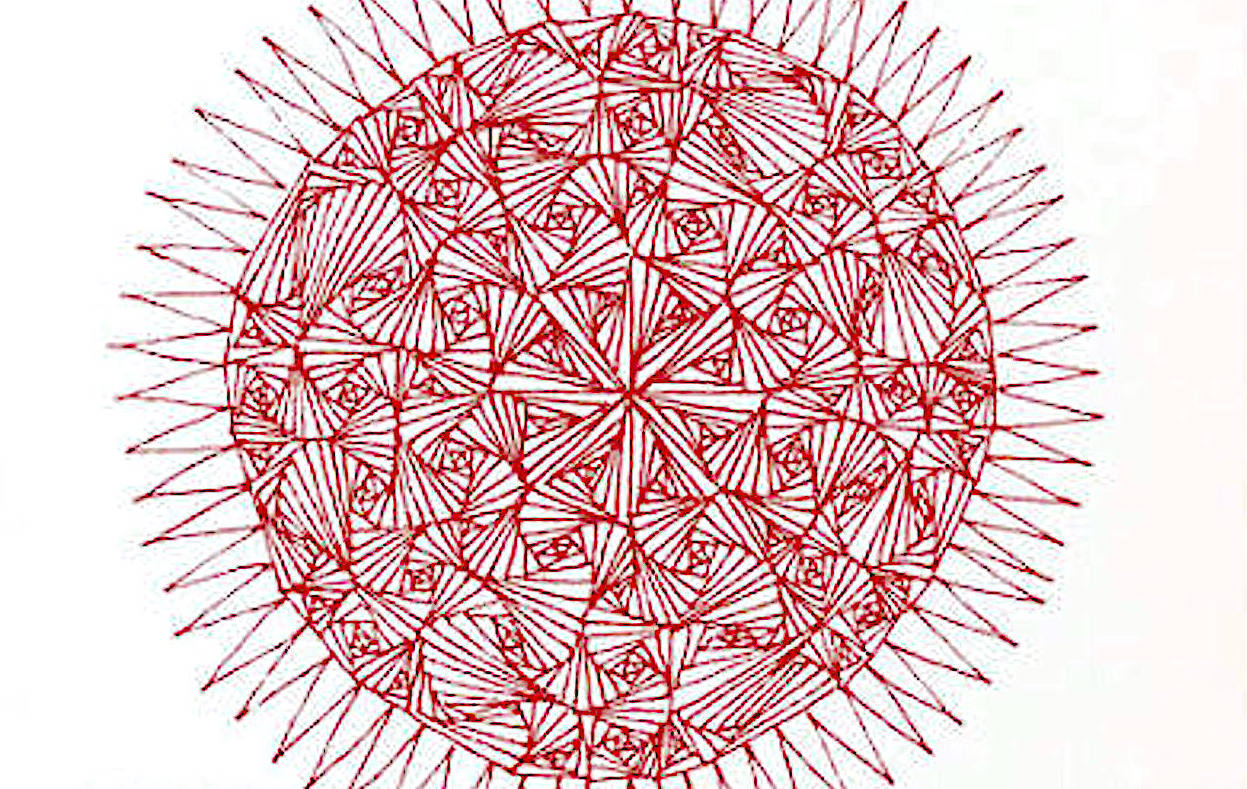Nella storia letteraria italiana, la figura del mago, nei panni di psicoanalista junghiano, geniale ed eccentrico, è incarnata da Ernst Bernhard, berlinese di stanza a Roma e ivi scomparso nel 1965.
Scartando Bernhard, per una volta, ci avviciniamo prudentemente a un suo allievo e collega altrettanto misterioso, in quanto nascosto in sé a doppia mandata, l’italiano Mario Trevi (1924-2011): ce ne serve oggi il ritratto, attraverso un romanzo nutrito di ricordi famigliari, uno dei più abili scrittori di memoria della nostra scena, Emanuele Trevi – cognome uguale a Mario: e infatti Emanuele è il figlio.
La prudenza, prima evocata, anzi una paziente cautela, appartiene a Emanuele. La casa del mago (Ponte alle Grazie, finalista al Campiello 2024) è il rischioso tentativo privato, raccontato in pubblico, di vivere tra le anime sospese che abitano l’appartamento del padre scomparso e di sciogliere l’enigma di un uomo eccezionale; questo appartamento, posto in un gradevole palazzo degli anni Venti è diventato il buio antro del guaritore, il luogo privilegiato dell’alchimista, seduto alla sua enorme scrivania, e sembra scoraggiare con invisibili messaggi percepiti sulle onde dell’inconscio i compratori, come serbasse in sé un segreto lascito del grande psicoanalista. È così: Trevi jr vi vede l’aggirarsi permanente di una Psiche sofferente e i segni, anch’essi disturbanti, della Cura, ossia dell’attività ardita e certosina che stremò per tutta l’esistenza il terapeuta.

Ci sono occorsi dieci e più anni dalla morte di Mario Trevi, perché Emanuele Trevi scrivesse di lui, anche se ci aveva già fatto i conti da vivo in un bellissimo libro-intervista, l’ormai introvabile Invasioni controllate (Castelvecchi 2007) – libro i cui incontri registrati Mario Trevi chiamava “la tortura”.
Almeno all’inizio, ne La casa del mago, prevale il divertimento grazie agli aneddoti di un bambino alle prese con un genitore dal carattere notoriamente impossibile – “sai com’è fatto lui” è il refrain della madre e indimenticabile resta un viaggio a Venezia; ma la piacevolezza del racconto, quasi fosse un modo per ingraziarsi la simpatia del lettore oltre (forse) quella del potente mago, passa anche per il personaggio mite e a tratti comicamente inetto, che è il cinquantenne Emanuele del libro.
La mossa decisiva del figlio per affrontare il ricordo del padre sarà quella di acquistare lui stesso l’insidiosa casa del mago, quella che nessuno vuole, e trasferirvisi, piazzando il letto, guarda caso, in quella che era la sala d’attesa dei pazienti.
Il percorso di Emanuele sarà quindi fatto di memoria e di acquisita conoscenza, mentre scopre una copia annotata da Mario, neanche fosse un compito in classe, di Simboli della trasformazione di Carl Gustav Jung oppure quando assolda per le pulizie una peruviana magica al contrario, una incaica Mary Poppins della sciatteria. Non sarà la sola donna ad apparire in pagine che si apriranno non sempre armoniosamente al romanzesco secondo un richiamo jamesiano (“il balzo della belva”): rievocate dalle antiche vicende della (forse) schizofrenica Miss Miller, analizzata da Jung, le donne si incarneranno in una sfuggente Visitatrice e poi in un pigra amante di nome Paradisa…

Gli apprendimenti del figlio del mago, aiutati anche da un fantasmatico cameo di Ernst Bernhard, si manifestano formalmente nel gran numero di aforismi, i quali garbatamente, senza supponenza, affiorano nel percorso del testo costruito in brevi tappe: si formano quasi in autonomia come “perle” o come “cicatrici”, lasciando l’impressione che il percorso possa assomigliare a una sorta di terapia e far sì che la saggezza del mago, acutamente e brillantemente interpretata e svelata dal figlio, che gli è poi simile, ricada anche su di noi semplici lettori.
Copio solo poche parole del racconto, per non banalizzarlo estraendo le frasi dal contesto: “Tutte le terapie, se ridotte all’osso, si assomigliano, consistendo nel lenire il dolore e allargare l’orizzonte, la prospettiva. Più la prospettiva è larga, più è facile accettare di stare al mondo”.
A margine. Posso aggiungere, sotto forma di domanda, che libri come quello di Trevi, anche prescindendo da giudizi critici di valore o di piacere della lettura, sono preziosi perché, nell’Italia di oggi, usano modi e raccontano mondi che sembrano espunti dalla quotidiana riflessione e comunicazione? Ma poi: è davvero inattuale (o addirittura vintage) come pare, rievocare tramite il mago Mario Trevi la visione e la pratica della psicoanalisi, freudiana o junghiana che sia? Non è neppure questo il punto. Il punto si trova, ritornando a Trevi – Emanuele questa volta – nel significato della scrittura come possibile testimonianza in quanto interna a una tradizione letteraria. Fuori da questa, navigando senza bardotti nell’enorme campo apertosi sotto la protezione della parola memoir, si rischia soltanto la cronaca di amori e malumori, il diarismo dell’irrilevanza. Senza magia.
Di Emanuele Trevi, abbiamo già scritto qui Di Ernst Bernhard, qui