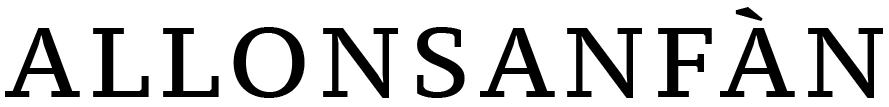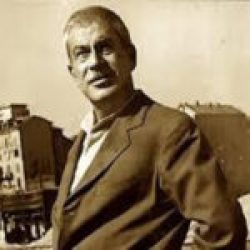«Napoli, a prescindere dai dintorni, si compone di tre strade in cui si va sempre e di cinquecento strade in cui non si va mai. Le tre strade si chiamano Chiaia, Toledo e Forcella. Le altre cinquecento non hanno nome: sono l’opera di Dedalo, il labirinto di Creta, con il Minotauro in meno e i lazzaroni in più».
Questa descrizione non appartiene a un romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, nemmeno a un’inchiesta o a un documentario sulla città italiana più sottoposta alle analisi sociali e ai luoghi comuni.
Queste parole appartengono ad Alessandro Dumas che pubblicò nel 1843 un libro dedicato a Napoli. Il titolo originale è Le Corricolo, il corricolo, un carretto leggero usato a quei tempi per poter percorrere i vicoli della capitale borbonica. Il titolo italiano del libro, uscito a fine 2024, è Leggende, fatti e meraviglie di Napoli (edizioni Quidlibet, Macerata).
L’autore de I tre moschettieri e Il conte di Montecristo, nell’estate del 1835 in “vacanza” a Napoli, abbandonò gli itinerari del Grand Tour per percorrere col corricolo le strade dei lazzaroni, osservando, prendendo appunti, parlando con la gente del luogo, raccontando le leggende che scorrevano tra i vicoli di una città che ha subito amato, dove una grande miseria conviveva con lo sfarzo della nobiltà e gli agi della borghesia.
I molti racconti sulle sue giornate napoletane scritti con grande maestria accompagnata da vivacità, satira e ironia, sono bellissimi e ancor oggi attuali: quelli sui “lazzaroni” – termine per lui non dispregiativo – e sul malocchio, hanno una visione sociologica. Poi c’è anche quello sulla pizza, che Dumas trasforma in un breve saggio sull’economia della città.

Spiega che la pizza con l’olio, la pancetta, lo strutto, i pomodori, le acciughe, diventa il termometro dell’andamento del mercato: il suo prezzo varia a seconda dell’abbondanza o della penuria di quegli ingredienti nel corso dell’anno.
«Quando la pizza ai pesciolini costa mezzo grano, vuol dire che la pesca è stata buona; quando la pizza all’olio costa un grano, significa che il raccolto è stato cattivo». E al riguardo della freschezza della pizza aggiunge: «Si capisce che non si può più vendere la pizza del giorno prima allo stesso prezzo di quella della giornata; vi sono, per le piccole borse, pizze di una settimana». Ma qui Dumas si sbaglia perché non sono mai esistite a Napoli pizze tanto stantie. Aveva interpretato male la frase “pizza oggi a otto” che in realtà significava “la pizza con pagamento a otto giorni”.
A proposito degli alimenti base del popolo napoletano aggiunge: «Se la pizza viene considerata un nutrimento invernale, il primo maggio cede il posto al cocomero; ma sparisce solo la mercanzia, il mercante rimane lo stesso. Il mercante è l’antico Giano, con una faccia che piange sul passato e un’altra che sorride all’avvenire. Nel giorno indicato, il pizzaiolo si fa mellonaro (in italiano nell’originale)». E sul cocomero aggiunge che con esso «si mangia, si beve, ci si lava la faccia».
Ma oltre al mondo dei lazzaroni, Dumas ha frequentato quello della nobiltà: parla del teatro San Carlo, dei suoi cantanti e dei loro agenti; del mondo della cultura; dei segreti delle grandi famiglie; del sovrano Francesco I, detto Re Nasone, noto per la sua ottusità; scrive inoltre sugli scavi di Pompei, sul Vesuvio e rivela tanti miti napoletani come il miracolo di San Gennaro, raccontando nei particolari la storia del santo, con il rituale che è rimasto immutato sino ai nostri giorni.
La vacanza napoletana durò circa un mese. Fu costretto a lasciare Napoli e il regno borbonico perché vi era entrato con falsi documenti. Dumas era noto alle polizie degli Stati italiani per le sue idee liberali e repubblicane e quando nel giugno del ’35 decise il Grand Tour in Italia, arrivato a Genova, le autorità piemontesi gli intimarono di lasciare il regno. Passò nel Granducato di Toscana dove non ebbe problemi e dopo una sosta a Livorno si fermò per un mese a Firenze dove scrisse Une année à Florence.
Quando decise di andare a Napoli, l’ambasciata borbonica gli rifiutò il visto di entrata nel regno. Decise di partire ugualmente convincendo l’amico Joseph Guichard a cedergli il suo passaporto. A quei tempi le fotografie non esistevano ancora.
Così sotto falso nome poté trasferirsi nel Regno delle due Sicilie dove il caso volle che un giorno incontrasse il marchese Vincenzo Salvo, noto come informatore della polizia, conosciuto a Parigi anni prima.
A malincuore lasciò Napoli prima che arrivasse l’ordine di espulsione. Ma vi ritornò molti anni dopo, nel 1860, al seguito di Garibaldi, raggiunto in Sicilia dove si era recato col proprio brigantino carico di armi da donare al generale.
A Napoli fu nominato “Direttore degli scavi e dei musei”, carica che mantenne sino al 1864, quando rientrò a Parigi.
In quegli anni di permanenza creò anche un quotidiano, L’Indipendente, il cui segretario di redazione fu Eugenio Torelli Viollier, che poi nel 1876 fondò a sua volta Il Corriere della Sera, a Milano.

Ai nostri giorni, a parte il meraviglioso teatro di Eduardo De Filippo, è difficile trovare una descrizione autentica di Napoli e del suo spirito, come Le Corricolo. Vi ha tentato Paolo Sorrentino col film Parthenope, ma penso che abbia ecceduto nell’esprimere il proprio rancore verso la sua città natale.
Invece vi è riuscito, sempre col cinema, il regista-attore americano John Turturro con il film-documentario Passione, girato a Napoli nel 2010.
Il film racconta con aneddoti, interviste, video d’epoca e con le secolari canzoni classiche napoletane quella che è la città dei vicoli, popolare, folcloristica e la sua storia. Gli attori sono persone incontrate per strada, gli abitanti dei “bassi”.
La musica accompagna la cinepresa che coglie “i lazzaroni” mentre parlano, cantano, vendono frutta e verdura, pesce, sigarette e tante altre cose dietro i banchi improvvisati. «Questa città è “dipinta” di suoni, e la musica ne è un elemento essenziale» disse Turturro in un’intervista. Come fosse l’eco di una frase di Dumas: «A Napoli le campane non suonano ma cantano».
- Immagine in apertura: Il corricolo napoletano descritto da Dumas
- Tutte le illustrazioni sono stampe dell’Istituto di cultura francese