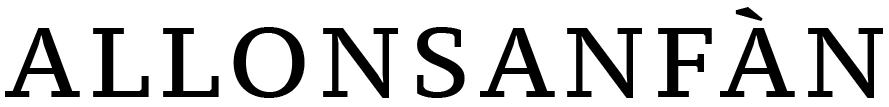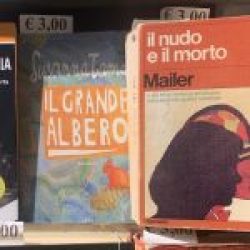Mentre va in taxi all’ospedale psichiatrico, Donald Antrim telefona al padre alcolista e gli dice che spera che “all the king’s horses and all the king’s men” lo rimettano in piedi.
È una citazione da Lewis Carroll, riguardante l’irreparabile rottura di Humpty Dumpty, e nell’originale indica il contrario esatto di quello che in apparenza auspica Antrim, forse per tranquillizzare il genitore: significa l’impotenza del re in determinate circostanze. Troppo semplice interpretare la citazione facendo del futile freudismo. Ma il malato forse sfida ironicamente o sarcasticamente (ed è la prima volta e unica volta in cui fa dell’ironia o del sarcasmo nel testo) la figura parentale…
Non aspettatevi psicoanalisi da salotto bensì piuttosto la Tec, versione riammodernata dell’elettroshock, da Un venerdì di aprile (Einaudi, ottimamente tradotto da Cristiana Mennella, come Auster e Saunders), racconto spaventevole di un uomo in pezzi che si presenta in un torrenziale piccolo libro (ossimoro), significativamente non diviso in capitoli, mentre fa le prove del suicidio, in calzini, sul tetto della sua casa di Brooklyn.

Un venerdì di aprile è il nuovo memoir di Donald Antrim, dopo quello per lui faticosissimo – e in parte, afferma, responsabile della situazione in cui lo troviamo ora – dedicato alla madre (La vita dopo, Einaudi). Contiene una colata di disperazione e di sintomi invalidanti che lo scrittore non vuole chiamare “depressione”, termine reputato troppo accogliente, ma “suicidio”, indicando il corso della malattia come il suo probabile esito.
La condizione del malato è sancita dalla solitudine. Chi gli è intorno vive nel tempo storico (passato, presente, futuro), lui nel tempo dell’eterno morire. Lo stesso spazio circostante, fuori dall’ospedale in cui viene ricoverato, gli è estraneo, precluso al ritorno. Antrim scopre di non aver noi smesso di morire, di essere stato malato di “suicidio” anche quando da ragazzo ha creduto di aver superato il disastro della sua infanzia, trascorsa tra sopraffazioni e molestie: non l’hanno salvato la terapia, i dodici passi, la scrittura, il rapporto con gli amici e con le donne. Fino a quando, divenuto uno “psicotico” che può essere curato solo con la Tec, Antrim vince la paura della terapia elettroconvulsivante e la accetta dopo aver ricevuto una telefonata incoraggiante da un illustre sodale, David Foster Wallace… Antrim forse cambierà e mano mano che il testo procede si allontana dal tetto della scena iniziale e si avvicina di nuovo alla vita, raccontandola e lasciando una cospicua biografia finale che ha saputo sciogliere nel testo senza mai apparire sentenzioso.
Il memoir possiede due caratteristiche che lo rendono contemporaneo – e pure post modern come le prime stravolte prove narrative di Antrim, per esempio i racconti del New Yorker confluiti in La luce smeraldo nell’aria (Einaudi), dove dominavano la scena protagonisti incapaci di svolgere i compiti più elementari, gente nata sotto la stella dell’autodistruzione.
Infatti. Il personaggio che dice io in Un venerdì di aprile è difficilmente conoscibile, essendo un’entità esplosa all’interno di sé e nel circostante, frammentato percorso di scrittura, mentre le sue cosiddette avventure viaggiano al di fuori della norma, condite da un’esagerazione che (in questo caso purtroppo) le rende credibili e reali, come il più crudele degli spettacoli.

E arriviamo alla lunga riflessione finale sul suicidio, dove Antrim cerca di rovesciare i termini della questione. “Se accettiamo l’idea che il suicida sta cercando di sopravvivere, possiamo cominciare a descrivere una malattia”, scrive, spogliando l’atto della presunzione che sia frutto di una scelta razionale, di volontà o autodeterminazione. Spogliandolo del mito e dell’enigma, dell’aura che lo circonda…
Riguardo i rapporti tra letteratura e malattia: La vita dopo esce nelle librerie americane quando Antrim è in ospedale, e lui aggiunge ai pesanti sintomi che avverte nel fisico, un eczema sulla fronte. Quasi un mistico “terzo occhio”, scrive, oppure una sorta di lettera scarlatta, marchio di infamia? Forse dobbiamo rassegnarci, come spiega più tardi Antrim ai suoi studenti, al fatto che tutta la letteratura nasce da un “trauma”. E sperare che la solitudine della scrittura non collimi con la solitudine nella vita.
(Credit: Audio Interview with Donald Antrim” by Literary Tourist is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.)