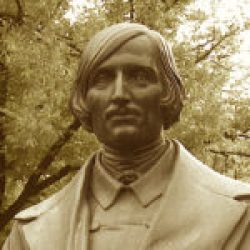“L’arte di vivere è l’arte di dimenticare”. “Il tempo deforma la vera misura dei fatti”. “Al Nord la vita e la morte erano più reali” – accadevano in un modo più brutale, le sentenze capitali potevano essere eseguite anche da un prigioniero a picconate.
Da questi tre postulati si ricava l’impossibilità di ricordare e di raccontare tutto ciò che è insopportabile, come l’esperienza della deportazione nelle gelate miniere della Kolyma.
Kolyma è una delle zone più remote e fredde della Russia, una distesa di paludi e ghiacci nella Siberia nordorientale, dove la temperatura scende fino a 60 gradi sotto zero, e i turni di lavoro dei deportati sono (almeno d’estate) di dieci ore al giorno con un giorno ogni dieci di riposo, ma possono salire a quattordici ore, senza contare le corvée per raccogliere la legna per il riscaldamento, per sé o le guardie.
Varlam Šalamov (1907-1982) ricorda nel 1969, con le grandi difficoltà cui ha accennato, l’approdo e la vita impossibile nelle miniere, dopo il suo secondo arresto, per attività controrivoluzionaria trockijsta.

Quando arriva all’estremo nord, sa che preferisce essere ammazzato piuttosto che lavorare per chi l’ha imprigionato o peggio ancora diventare un caposquadra, colui che incoraggia a darsi da fare e intanto, per questo, condanna a morte gli altri. Šalamov è assegnato alla miniera Partizan dall’agosto del 1937 fino al dicembre 1938, quando viene arrestato nel caso, arrangiato, detto “dei giuristi”. Ha per nemici il freddo – solo da meno 55 in giù non si lavora -, la fame, le energie sempre in punto di svanire, le botte continue, persino il ringhio dei cani. “Il lager è il trionfo della forza fisica in quanto categoria morale”, afferma. Non c’è spazio per una vita interiore che non sia rudimentale, sfocata, liminale a un’incoscienza da stremati morituri, talvolta carnefici di se stessi, neanche divisi da ciò che erano prima: stanno tutti insieme gli intellettuali, i contadini, i “comuni”. Nel capitoletto Cosa ho visto e capito nel lager, uno stringato elenco in 46 punti, Šalamov annota subito che l’uomo diventa una bestia in tre settimane, a prova della “eccezionale fragilità della cultura e della civiltà umane”. Non per caso, pochi paragrafi avanti denuncia diversi casi di cannibalismo.
Il libro che abbiamo in mano, Tra le bestie la più feroce è l’uomo, si affianca ai celebri Racconti della Kolyma, che comparvero, in edizione completa, in Occidente nel 1978 e in Russia solo nel 1987, e raccoglie scritti per lo più degli anni Cinquanta e Sessanta, tratti dalle due edizioni di ricordi di Varlam Šalamov, curate da Irina Sirotinskaja – Vospominanija, Moskva, 2001; e Novaja Kniga. Vos pominanija. Zapisnye knižki. Perepiska. Sledstvennye dela, Moskva, 2004; traduzione italiana di Claudia Zonghetti.
Lasciando all’esperienza del lager la più consistente parte, Tra le bestie la più feroce è l’uomo presenta dapprima, in ordine cronologico, i testi di un altro mondo, narrando la Russia ebbra di speranza degli anni Venti, il lavoro in fabbrica scelto per maturare un nuovo atteggiamento vitale e politico, consono a tempi che si credono maturi per la rivoluzione mondiale, e intanto illustra l’accesa tenzone letteraria, il florilegio di iniziative che rimbalza da Leningrado a Mosca, Mosca divenuta “l’università della cultura”. Tra quelli di Majakovskij e Bulgakov, Blok e Pasternak, scorrono nelle pagine decine di nomi da seguire – e magari da ripescare, tradotti da Angelo Maria Ripellino – mentre cercano di spingere più in là la linea dell’orizzonte dell’espressione – per esempio, meriterebbe un capitolo a sé l’avventura della rivista in carne e ossa Giubba Blu…

Varlam Šalamov scopre ben presto che in fabbrica perde tempo e risolve diversamente la sua formazione anche se la militanza intellettuale (tra coloro che in miniera saranno beffardamente chiamati gli Ivan Ivanovič) lo conduce dritto agli arresti nella Mosca già mutata degli anni Trenta.
Šalamov trascorrerà lunghi anni all’estremo nord, prima come minatore, poi come infermiere negli ospedali e cantieri forestali, e farà ritorno solo nel 1953 nei pressi di Mosca: sarà riabilitato ufficialmente nel 1956. C’è quindi un “dopo Kolyma”, per lo scrittore provato nella salute, che fa capolino nell’ultima parte del libro, dove compaiono una prova di romanzo-saggio, una novella, e ritratti di sodali. Due su tutti sono essenziali: la trascrizione di una serata moscovita del 1956, dedicata a Osip Mandel’štam, morto nel 1938 in un lager di transito vicino a Vladivostok. Šalamov vi partecipa (“pallido, gli occhi spiritati”), leggendo un suo racconto della Kolyma, lo splendido Cherry-brandy, incentrato sulla morte del poeta. Il secondo ritratto (vale il libro) è ancora più importante per la comprensione di Šalamov: quello di Boris Pasternak, cui lo lega una profonda consonanza poetica e umana; alla sua porta, in vicolo Lavrušinskij, così turbato da non riuscire nemmeno a suonare il campanello, Šalamov si presenta dopo i suoi diciassette anni passati all’inferno, appena dopo aver rivisto la moglie e la figlia, che aveva lasciato neonata.
Tra le bestie la più feroce è l’uomo è un testo che corre parallelo a I racconti della Kolyma. Non li sostituisce affatto ma li integra vivamente, in senso non solo documentario o testimoniale. I racconti e i ricordi di Varlam Šalamov, paragonato a Solženicyn e a Primo Levi per la condanna al totalitarismo che nel lager non ha una crudele eccezione ma le sue fondamenta, sono più che mai attuali. Leggere e parlare davvero di dittature oggi, in un momento storico in cui l’Europa e l’Italia populista le vezzeggia con annoiata e presupponente sufficienza, rimane un gesto di civiltà.
A margine. Se volete leggere Cherry-brandy, qui. “Il poeta stava morendo. Le sue grandi mani, rese gonfie dalla fame, con le bianche dita esangui e le unghie sporche, lunghe, cilindriche, erano appoggiate sul petto e non cercavano più riparo dal freddo. Prima se le ficcava in seno, sul corpo nudo, ma adesso neanche lì c’era abbastanza calore. Le manopole gliele avevano rubate da tempo; per rubare era sufficiente la sfrontatezza, lo facevano in pieno giorno. Un sole elettrico smorto, lordato dalle mosche e ingabbiato in una griglia circolare, era fissato al soffitto in alto. La luce cadeva sui piedi del poeta: egli era disteso, come in un cassetto, nell’oscura profondità di un giaciglio al piano inferiore dell’ininterrotta teoria di tavolacci a castello…”.