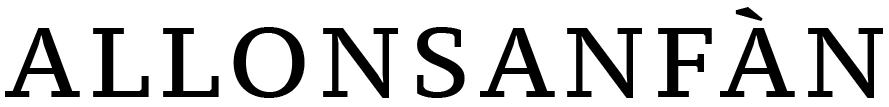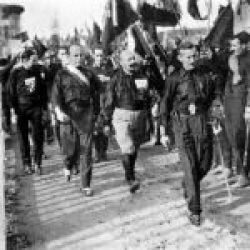Molto più che un reportage. Una presa diretta avvincente. Narrazione, contestualizzazione storica e poesia del dettaglio. Una giornalista che propone all’attualità drammatica di sempre lo sterminio di una minoranza etnica e religiosa: gli yazidi, decimati dall’Isis nel 2014.
Sara Lucaroni è autrice del libro La luce di Şingal. Viaggio nel genocidio degli yazidi (People) e non è nuova all’esplorazione delle vicende belliche, umane dell’area medioorientale e centroasiatica.
Con questo libro conia un prodotto nuovo, originale. Recupera la memoria, fra il diaristico e la cronaca, del suo vissuto di giornalista quando effettuò un viaggio, a luglio e agosto 2015, alla scoperta del genocidio degli yazidi; subito si butta a capire come e perché il genocidio avvenne, quale ricchezza umana e sociale quella minoranza possedesse.
Le pagine scorrono, si leggono con forte partecipazione. Non sono un mero succedersi di eventi, ma un crescente collage di natura, paesaggi, azioni e pensieri, persone e gruppi, ruoli e tradizioni. La scrittura non esita, giunge subito diretta, senza ridondanze o retorica frequenti anche nelle corrispondenze di guerra. Periodi corti, pochissime subordinate, punteggiatura essenziale. Certamente più limature del testo, per offrire al lettore immediata incisività.

A ottobre del 2014 Sara riceve una telefonata dalla Siria. Tre squilli insistenti. È un contatto sconosciuto, una richiesta di aiuto da parte di Ghazi Murad Barakat, amico dell’artista Ali al Jabiri di Baghdad.
Sui monti del Sinjar – Şingal, in curdo – area al confine siriano, nel nord del Kurdistan iracheno, erano riparati centinaia di bambini e poche donne, fuggendo dagli assedi e genocidi compiuti dallo Stato Islamico, denominato Daesh, secondo l’acronimo arabo, più generalmente Isis.
Lucaroni decide di partire e recarsi fra quelle montagne. Così descrive la scelta: “Sono partita come giornalista, senza esperienze di quel tipo sul campo e senza i mezzi che gli inviati di una testata hanno garantiti, ma soprattutto sono andata a Şingal come persona. Vediamola da vicino, la guerra. Iniziamo da questa. Additiamone, con tutte le forze che ho, l’immensa imbecillità, ho pensato… E ho capito che quel che succede a migliaia di chilometri dal mio e dal nostro studiolo, o anche dall’altro capo del mondo, è affare di tutti… Non esistono luoghi lontani o gente sconosciuta: siamo tutti la stessa identica umanità”.
Il viaggio d’inchiesta. Sara si trattenne solo dal 20 luglio al 10 agosto 2015, un assaggio breve ma intenso, sufficiente per assumere le misure di un dramma umano, sociale, culturale: l’annientamento di una comunità. Pensiero esplicito: un gruppo di fanatici che riesume il medioevo della civiltà, vuole imporre le sue leggi sul mondo e in dieci giorni stermina una comunità, come prova di forza e bottino di guerra perché lo vuole Dio.
Lucaroni raggiunge l’area in parte libera, accolta dalla comunità sopravvissuta e accompagnata dalla scorta militare. Sempre in compagnia della fotocamera e del pc, a singhiozzo per la carenza di energia elettrica o di batterie. Essenziali pennellate per farci cogliere il paesaggio: “…le case sono salve giusto sulla strada a inizio viaggio: muretti bassi di cortili in cui scorrazza qualche gallina, un filo di panni stesi, pochi olivi e un albero di melograno, cinque o sei pecore che masticano stecchi guidate quasi sempre da bambini… Anche le case più isolate sono state distrutte, e lì intorno il vento sulla sterpaglia piatta a perdita d’occhio è l’unico rumore… Le moschee sono state distrutte come il resto e gli altoparlanti muti svettano ora su minareti metallici inclinati fino a terra che sembrano antenne in disuso…”.
Tratti narranti e fotografici, a pari tempo. Una singolarità dell’autrice, mix di scrittura e immagini evocate perché viste, dove il sostantivo si contamina con l’aggettivo in una ambivalenza unica. Mi ricorda la scrittura di Beppe Fenoglio, allorquando il sostantivo diventa verbo e movimento, ovvero l’aggettivazione si fa sostantivo.
Ancora tratti essenziali per i protagonisti. Sabah è un giovane soldato yazida ventenne, accompagnerà Sara nel viaggio. È un resistente. Sara verrà ospitata da una famiglia. Anche qui, mi pare di cogliere un’ispirazione fenogliana, quando Sara descrive “hanno tutti gli stessi identici occhi, grandi, allungati, neri, con un’involontaria espressione dolce anche quando non serve… la timidezza gentile di Sabah…”. Fenoglio molte volte esitava e insisteva sui tratti fisici, anatomici del corpo umano, sugli atteggiamenti espressivi, quasi per voler dare loro la parola.

La storia e l’oggi. Sara annota: “…Il Tigri è a fianco del checkpoint. L’ho guardato a lungo. È il fiume delle pagine di storia degli Assiri e dei Sumeri… Ci vive il Dio del tempo: la sera, calato il sole, si ritira sotto le sue acque. Ci custodisce la memoria della terra e le storie di tutti gli uomini vissuti qui…”.
Questa terra è oggi intrisa di sangue e violenza dell’Isis. “…È stato un attacco a tenaglia, da Mosul, Tal Afar, Al-Ba’aj e Rabi’a risalendo villaggio per villaggio, tra la fine di luglio e metà agosto. Circa 450 mila persone sono fuggite da Şingal e da tutta Ninive: cristiani, turkmeni, musulmani sciiti, shabak, mandei, anche gli africani e gli arabi delle paludi. E gli yazidi, la minoranza contro cui l’accanimento è stato scientifico: diecimila persone uccise o scomparse, di cui settemila donne e bambini rapiti… Uomini, adolescenti, anziane e anziani, rifiutando di convertirsi, sono stati fucilati, decapitati, sgozzati. Si ha notizia di persone disabili bruciate vive. Ci sono decine di fosse comuni, e altre se ne stanno scoprendo. Sono ai crocicchi, sul limitare dei campi, lungo le strade, in buche per i rifiuti e sul retro di certe case, fuori e sotto cumuli di terra dove qualcuno ci è finito da vivo”.
Le evidenze Attingendo al capitolo secondo: “…Queste sono due guerre in una, in contemporanea: quella pubblica, sotto i riflettori della Coalizione internazionale che già il 9 agosto aveva iniziato coi bombardamenti; e la guerra privata, sconosciuta, che è un racconto orale che si tramanda e che nessuno scrive. Una guerra fatta di retrovie, incoscienza, spari pieni e a vuoto, attese, notti al buio, sopravvivenza, fame, fughe, eroismo, disperazione, impreparazione, tenacia, morte. A condurla sono stati i primi yazidi che hanno impugnato le armi, come la banda. Far cadere la montagna sacra sarebbe stata davvero la fine”.
La violenza dell’Isis e il dramma collettivo. Della tragica fine del territorio di Kocho parlano tutti poco. Lucaroni osserva: “… È il luogo cancellato, è il paese cimitero, l’unico di tutta la piana in cui il Daesh ha tenuto una strana lunghissima trattativa prima del solito epilogo, previsto e spaventoso. È la strage peggiore, perché nata dal dubbio della speranza”.
Lucaroni, come in tutto il libro, anche qui narra le violente vicende compiute dal Daesh nel pieno di una precisa ricostruzione storica locale e più complessiva. Narra di come “…alla tv passano tutto il giorno le scene dell’esodo e dei morti lasciati sulle strade, gli elicotteri americani sulle vette a cui i profughi si aggrappano per salvarsi, le testimonianze delle donne rapite per diventare schiave sessuali appena fuggite dalle loro prigioni. Intorno c’è l’Apocalisse, ma Kocho è oggetto di una specie di silenzio stampa…”. Nel capitolo quarto, ancora dramma e natura, persone e torti subiti. “…Kocho è ancora lì. Fermo a un anno fa. Quanto stride la bellezza della montagna con quelle fosse e con le case svuotate dei propri legittimi visceri umani…”
Coraggio e speranza oggi. Sara Lucaroni narra, ricostruisce una storia, la scava nel suo profondo, ma poi la compara con l’oggi, con l’etica e la speranza di oggi. A Şingal ha incontrato resistenti giovani, coraggiosi, quasi impossibili al successo, tenaci, con ancora un po’ di luce negli occhi. Sara e scrive e scolpisce: “In tante culture e in tanti Paesi la resistenza a una dittatura, alle discriminazioni, a un genocidio, all’apartheid, a una legge liberticida è un tratto fondamentale della coscienza civile. La resistenza più che per scelta si impone per etica perché, oltre che col destino dei presenti, ha a che fare col futuro, con quello di chi verrà”.

Una chiosa. Ho letto e riletto il libro di Sara, come non sempre faccio. Ogni volta ho attinto emozioni nuove. Non conoscevo affatto la vicenda storica e bellica, se non per il premio Nobel per la Pace assegnato nel 2018 alla giovanissima venticinquenne Nadia Murad Basee, nativa di Koio o Kocho, piccolo paese sul fianco del monte Sinjar, oggetto della pulizia etnica compiuta dall’Isis nell’agosto 2014. Fu venduta a un giudice dell’Isis, venne struprata ripetutamente, riuscì a fuggire e raccontò a mezzo mondo le violenze dell’eccidio degli yazidi.
La postfazione di Riccardo Nouri (portavoce di Amnesty International Italia) conclude: “…Il lascito del genocidio degli yazidi è ancora in corso. Tante ragazze risultano ancora scomparse, le ferite della violenza sessuale sono aperte e per ricucirle, fisicamente e psicologicamente, forse non basterà una vita intera. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui questo libro va letto e fatto leggere”.
Nelle pagine di Lucaroni ho trovato molta storia, ben ricostruita, ma soprattutto ho trovato molta umanità ed etica civile. L’autrice non solo racconta, ma penetra dentro alle vicende. Le esplora, le ravviva per l’oggi, cogliendo i tratti permanenti. Ha coniato un nuovo paradigma di giornalismo, composto da differenti approcci, tutti sincronizzati: rigore narrativo, contesto ambientale e socio-culturale, centralità delle persone e del pensiero, assunzione del particolare nella dimensione complessiva. Incontriamo pagine di cronaca, di vissuto diretto, di storia e di dramma collettivo, di grande ingiustizia, ma anche di poesia e di speranza.
Su Avvenire del 3 agosto 2024 Sara Lucaroni ci ha regalato un pezzo denso di concretezza storica e di partecipazione umana e sociale: “A dieci anni dal genocidio dell’agosto 2014, gli yazidi sono soli con il loro dolore… non è vero che il tempo allevia il dolore, gli yazidi curano se stessi con la resilienza …”. Non tutto è perso, vale la pena resistere per un nuovo umanesimo.