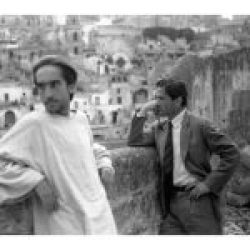Nota Nicola Lagioia (Bari, 1973) ne La città dei vivi: “Vivevamo nell’epoca dello storytelling, un periodo in cui professionisti senza scrupoli maneggiavano l’armamentario con cui si fabbricano le storie di finzione per creare consenso e alimentare odio”.
Eppure, per raccontare la storia di un crimine – l’assassinio del ragazzo Luca Varani finito intrappolato nella deriva drogata degli amici Manuel Foffo e Marco Prato – si può tornare a un’era precedente.
Lagioia scarta a piè pari pure il reportage giornalistico finto oggettivo, che non esiste neanche nella più nobile versione british, così come il romanzo dell’intellettuale che impone le mani sulla volgare materia del reale e ci regala il suo insight da veggente.
Lagioia torna, senza ingenuità e con tutte le malizie del caso, al giornalismo letterario alla Truman Capote. Per il mitico A sangue freddo (1964), uscito a puntate sul New Yorker, lo scrittore americano aveva applicato una ricetta semplice quanto efficace: si era recato sul luogo del delitto, in Kansas, là dove era stata sterminata la famiglia Clutter, ci era rimasto quanto gli pareva, e aveva scritto tutto come gli andava.
Senza ingenuità: Lagioia sa che chi guarda fa egli stesso parte del panorama (Rovelli docet), vede ciò che può o che vuole vedere, e al meglio può allargare il più possibile il campo o approfondire lo sguardo sui dettagli. Conosce del resto le ragioni profonde per cui si è dedicato a questo caso e lo spiega a se stesso e a noi mano a mano che procede con la narrazione.
Si permette così la prima persona, cioè il dire io – usa invece come mezzo di distanziamento l’uso costante del tempo imperfetto -, lascia al suo talento la costruzione di una seconda storia, carsica rispetto alla pista principale dell’indagine, e offre una descrizione concreta, quasi visiva, del teatro del crimine – verrebbe da dire “del martirio” perché siamo anche noi fruitori in automatico di modalità da storytelling nonché di tutti i luoghi comuni spesi dal giornalismo popolare, che qui Lagioia evita o spiega e smonta con un lavoro paziente.

La città dei vivi – oltre al tour de force di due “assassini per caso” secondo un’altra semplificazione del giornalistese – è una fotografia di Roma, che non produce più niente, solo potere che produce altro potere, e così via, senza progresso (Pasolini docet). Roma che solo apparentemente poteva essere in quel marzo del 2016 “…un discorso a parte. Sotto la pioggia era il discorso di un pazzo che, come di rado accade, conteneva squarci di verità”. Roma, in un’Italia dove “…nessuno riusciva più a imputarsi una colpa, nessuno riconosceva a se stesso la possibilità del male. Era il narcisismo di massa? Era la paura del biasimo sociale…?”
Lagioia è all’erta poiché nell’ora in cui c’è coscienza sul fatto che persino i principali cambiamenti del pianeta sono imputabili al nostro agire, non c’è esercizio difficile come ricondurre un effetto a una causa, e farlo su un piano individuale. Per questo nel pezzo di bravura di ricostruire il grande vuoto in cui sono risucchiati i carnefici Foffo e Prato si avvale di ogni possibile brandello di sapere e di ogni probabile punto di vista.
Alla fine del libro, che arriva a sei anni da La ferocia (Einaudi, 2014), resta sul campo di battaglia – tra scrittura e verità – una convinzione: “Nessun essere umano è all’altezza delle tragedie che lo colpiscono… Le tragedie, pezzi unici e perfetti, sembrano intagliate ogni volta dalle mani di un dio”. Questo stende una carezza di pietas – e l’impressione di un dibattersi che si imparenta al grottesco – su tutti i personaggi, umani e disumani, protagonisti e comparse di una storia infame perché, non partecipando al sacro, nemmeno hanno il conforto di una redenzione.
A margine. Non abbiamo raccontato il delitto perché la storia è nota. Per farselo raccontare, meglio Lagioia di Wikipedia.

IL LIBRO Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi