Ricorrenze. L’album Grace di Jeff Buckley fu pubblicato il 23 agosto 1994, trent’anni fa
Ma partiamo dalla fine… Nel Fiume del Lupo, il Wolf River, a Memphis, Jeff Buckley, già noto come Scott Moorhead, si è immerso vestito, il 29 maggio 1997, senza nemmeno togliere gli stivali: è arrivato fino ai piloni del ponte dell’autostrada canticchiando il refrain di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin… Those are people who died, chioserebbe Jim Carroll. Esiste un modo più stupido di morire/suicidarsi per davvero oppure per sbaglio?
Comunque. Prendo per buona la versione della morte di Jeff Buckley adottata, da subito, dalla madre Mary Guibert – un incidente – per il semplice fatto che nessuno saprà mai com’è andata. Non lo sa neanche Keith Foti, il testimone diretto, che trafficava col master blaster mentre l’amico si andava ad annegare. Era il giorno – uno scherzo del destino? – in cui i musicisti di Jeff stavano atterrando a Memphis per registrare le canzoni finalmente pronte di My Sweetheart the Drunk, il secondo very difficult album di Jeff, l’arduo seguito di quella fortunata meraviglia che era stato Grace.

L’imprinting degli Zeppelin
Guarda caso è dei Led Zeppelin, Physical Graffiti, il disco che apre a Buckley le porte del rock da ragazzo – gli è donato dal padre adottivo, Ron Moorhead, non da quello vero, l’immaginifico songwriter Tim, appena sfiorato in vita da Jeff. Ed è la canzone Kashmir, presa da quell’lp, che appare in una cover ironica in Live at the Olympia, registrato il 6 luglio 1995 e uscito postumo. Buckley fa lo svelto riff di chitarra di Jimmy Page e ci mette sopra la caricatura della voce sfrigolante di un simil Robert Plant. È un momento di divertimento durante il concerto che, in terra francese, ha già ispirato la vena di Buckley “americano a Paris”, il quale canticchia le Foglie Morte per gentilezza, oppure esegue Je n’en connais pas la fin per stringersi più stretto al pubblico parigino. Tra le otto cover di You and I, il disco postumo del 2016, c’è invece l’esecuzione ben più articolata di Night Flight, estratta sempre dai Graffiti Fisici di Page e Plant.
Chi conosce Jeff Buckley solo per la melodiosa e accorata cover di Hallelujah – parrebbe, a un ascolto distratto, un Leonard Cohen ben rasato, portato a spasso tra cherubini e serafini, praticamente il prototipo di canzone per affrontare e fallire le selezioni di X Factor ai quattro angoli del globo – si stupisce di quanto sia rock, elettrico e sporco, il ragazzo sul palco. Il produttore scelto per il secondo very difficult album, è del resto Tom Verlaine ex Television, che non c’entra tanto con la poesia francese del cognome quanto con la spigolosa new wave newyorkese. In seguito, nel making of a singhiozzo del disco, Verlaine viene rimpiazzato da Andy Wallace, che aveva già prodotto Grace.
Ma quanti Jeff Buckley, prima della nuotata con gli stivali, sono stati in giro? Jeff ovvero il figlio di Tim, padre mai conosciuto – il quale è morto il 29 giugno 1975 nella sua casa di Santa Monica per overdose di eroina e alcol – padre cui viene connesso per la vocalità strabiliante il cantante-usignolo di Grace; il folk singer e songwriter sofisticato che ha bazzicato i locali del Village, offrendo cover tutt’altro che karaoke, da Nusrat Fateh Ali Khan a The Smiths; il rocker che nella vita ha suonato e cantato già tutte le musiche, dall’heavy di quando si chiamava ancora Scott Moorhead al blues e che, ubriaco o peggio, non riesce a finire il nuovo disco a Memphis. Questi e quanti altri?
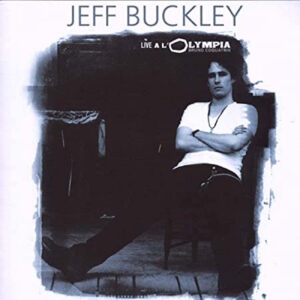
L’equivoco della Grazia
L’amore di Jeff Buckley per i Led Zeppelin (ricambiato tra l’altro) è stata una piccola leva per spostare il popolo degli ignoranti – prima quando accennavo ad Hallelujah, e potrei citare altri due momenti ecclesiali di Grace, parlavo di me – a scoprire le altre dimensioni di Jeff Buckley.
Tutta la musica che Jeff Buckley ha suonato era diventata per me nel ricordo come un fuori fuoco in cui avevo ritagliato il quadro vivido e limpido di qualche pezzo di Grace, un album che sarebbe stato – per dirla in modo un po’ ridicolo alla sussiegoso critico rock d’antan – di bellezza angelica e apollinea, e fuori dal quale si sarebbe prodotto il grande caos, con i demoni e Dioniso spesso domati e spesso no.
A farmi etichettare Jeff Buckley così – l’angelo buono e tutto sommato inoffensivo – aveva contribuito di rimbalzo la messe dei dischi live di Tim Buckley usciti postumi o diffusi sulle piattaforme online: mi sembravano, ascoltati distrattamente, prove libere di estenuate folk songs acustiche, lontane dall’avantgarde come dai groove degli album – che una volta consideravo – commerciali. Un titolo per tutti: Live at The Floklore Center, NYC, March 6, 1967.
Tim Buckley in questi live mi pareva un po’ una noia, uggiosa ma tollerabile, di canzoni psichedeliche, un flebile ululato più che una sirena d’allarme né tantomeno di Ulisse sottoposto al grattugiare delle chitarre a 12 corde. Breve: avevo messo – per via di parentela e per la mia sordità – nello stesso quadro sonoro il mio malinteso Grace e la parte meno rifinita dell’opera del padre.

Intorno all’Hallelujah
In questo gioco di scatole cinesi in cui mi sono ficcato vanno naturalmente risentite l’Hallelujah di Cohen – che in un primo momento non suscitò il successo a cui era destinata – e quella di Jeff Buckley, per pulirle dall’effetto canzone per virtuosi da X Factor e non solo da quello.
In primis, la canzone “non” è una canzone religiosa, nonostante abbia avuto fortuna – per un equivoco – anche nelle chiese del mondo: “non” lo è, in tutta la sua travagliata storia, che attraversa una lunga incubazione e continui aggiustamenti – secondo la leggenda, prima di inciderla Cohen avrebbe scritto e scartato un centinaio di strofe, poi ridotte a quattro, mentre è noto che allungò la canzone nelle versioni live, per inquietudine e in seguito forse per rifarla sua.
Comunque. L’Hallelujah (in ebraico “preghiamo Yahveh”) di Jeff Buckley non è quella incisa da Cohen in Various Positions nel 1984 – un album sfortunato, che non piaceva alla casa discografica Columbia, tanto che ne ritardò di un anno l’uscita negli Stati Uniti – ma è debitrice della cover incisa John Cale nel 1991: l’ex Velvet Underground lavorò su materiale fornitogli dallo stesso poeta canadese per l’album tributo I’m Your Fan, se ne infischiò abbastanza dei colti riferimenti all’Antico Testamento, e ne diede un’interpretazione ancor più secolare incentrata su un vasto spettro di luoghi emotivi.
In ogni modo (e nella sua versione): lo scopo di Cohen era parlare di tutte le Hallelujah possibili, “perfette o infrante” (“the holy or the broken”). L’Hallelujah essendo per lui in primo luogo (o in ultima istanza) un desiderio di affermazione di vita, che esclude significati religiosi “formali”.
Il punto per il poeta canadese – che nei versi si immedesima nell’adultero re David – “non è se Dio esiste o non esiste, quello che conta davvero sono le parole, la poesia, le emozioni: vere onde di luce” (da una lettura di Riccardo Petroni, che spiega il misunderstanding della canzone in ambito cristiano). L’affermazione finale che, comunque sia, rimanga da cantare un Dio della Canzone (un Lord of song) non sarebbe che “un atto di sprezzante e infinita superbia verso Dio”. Come da testo:
…And even though it all went wrong
I’ll stand before the Lord of song
With nothing on my tongue but Hallelujah…
Ciò non è un problema che tocca, almeno in maniera esplicita, Jeff Buckley. La sua Hallelujah – pezzo ascoltato da lui per la prima volta nel disco I’m Your Fan, scovato nella casa di Brooklyn della girlfriend Janine – deriva materialmente e spiritualmente da quella di John Cale: perdendo le due strofe conclusive più “teologiche”, e insieme il Lord of the song, e ponendo in stand by le tribolazioni di Cohen, si indirizza decisa sui terreni dell’amore e del sesso – il che porta Jeff Buckley a parlare, addirittura di una “Hallelujah dell’orgasmo”.
Sulla storia di Hallelujah, qui riassunta piuttosto brutalmente, è prezioso il volume di Alan Light The Holy Or the Broken (2012).
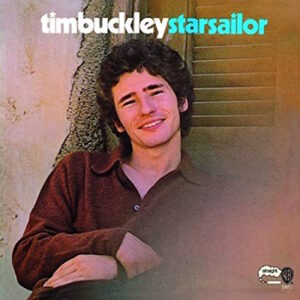
Tim Buckley in Italy
Nella mia percezione adolescenziale di rock fan, ovvero di lettore di Ciao 2001 – era un settimanale ben confezionato, con articoli pomposi e foto standard da casa discografica e io mettevo in conto che i giornalisti del Ciao fossero sul serio intimi degli artisti di cui parlavano e non che divinassero le loro mosse da fonti estere – secondo le letture del Ciao, dicevo, Tim Buckley era partito coraggioso menestrello con paroliere poeta bombastico (Goodbye and Hello), aveva proseguito con folli esperimenti (Starsailor), si era rifugiato, deluso dall’irrilevanza delle copie vendute, in un funk commerciale (Greetings from L.A.), non aveva fatto saltare il banco lo stesso ed era morto per una fatalità, da angelo non cattivo ma sfigato. Ecco: un altro giudizio tutto da riassestare, ma non qui.
Oi bioi paralleloi
Non riesco a prescindere, quando penso a questa doppia storia rock, quella di padre e figlio – di angeli e demoni, di Apollo e Dioniso ecc. ecc. – cominciata male e finita peggio, dalla canzone I Never Asked To Be Your Mountain di Tim Buckley, che Jeff sceglie di eseguire in un concerto-tributo organizzato dal leggendario Hal Willner (tra l’altro, requiescat in pace): Greetings from Tim Buckley, all’Arts di St. Ann, St. Ann’s Church, Brooklyn, New York, il 26, aprile 1991. Altri pezzi suonati da Jeff Sefronia – The King’s Chain, Phantasmagoria in Two e Once I Was. Finale a cappella.
Ma la prima, I Never Asked To Be Your Mountain, è una canzone speciale, quella con cui Buckley senior abbandona moglie e figlio – con cinismo, si dice, ma io non ne sono convinto – e ha in un verso un riferimento, neanche uscisse dalla Waste Land di T. S. Eliot, alla “morte per acqua”, con quell’incredibile I’m drowning.
Non è scelta casuale neppure Phantasmagoria in Two, di cui esiste un clip d’animazione relativo alla versione di Tim Buckley: contiene un idealizzato e impossibile quadro di vita famigliare.
Dice Jeff Buckley in una citatissima intervista a Rolling Stone: “…mi infastidiva non esser stato presente al suo funerale, non sarei mai più stato in grado di dirgli qualcosa. Usai quello show per dargli il mio ultimo saluto”.
Non è però l’ultimo saluto pubblico di un padre visto una volta sola o poco più. Il travagliato (perché inesistente) rapporto è al centro di una canzone di Buckley jr, What Will You Say?, che compare postuma su due live, Mystery White Boy e Live at the Olympia, in quest’ultimo in versione esotica con accompagnamento del vocalist azero Alim Qasimov. Nella canzone il figlio immagina una conversazione con il padre incontrato nell’aldilà.
Cantava Tim: Quel farabutto di tuo padre è scappato con una ballerina che chiama regina e gioca con le sue carte rubate e ride e non vince mai
Canta ora Jeff: Posso sentire il tuo tempo strisciare verso una fine lenta. Sento il mio tempo strisciare verso una fine lenta… Padre, mi senti? Mi riconosci? Hai anche scrupoli? Che cosa dirai quando prenderanno il mio posto?
Sul tributo e sul rapporto tra figlio e padre esiste anche un film (non un docu), Greetings from Tim Buckley, diretto nel 2012 da Daniel Algrant con Penn Badgley, noto per la serie Gossip Girl, nei panni di Jeff Buckley e Imogen Poots (poi in Roadies) in quello di una ragazza che ne intuisce il potenziale. Ben Rosenfield (poi in Boardwalk Empire) è Tim Buckley. Il film ruota attorno e culmina con la performance del 1991. Non sono ancora riuscito a vederlo.
Il cerchio si chiuderà sei anni dopo: tutto finisce dov’era iniziato. Il funerale di Jeff Buckley è celebrato il 1º agosto 1997 nella chiesa di Saint Ann a Brooklyn, il luogo in cui era partita la sua fiammante carriera nel Tim Buckley Tribute.
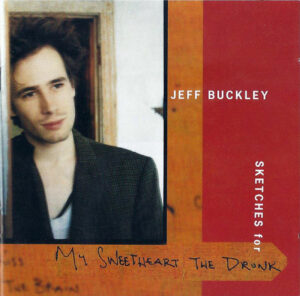
Sketches senza futuro
A margine, per il momento, si possono leggere i testi delle canzoni-presagio su Grace, Eternal Life e The Last Goodbye: si può trovare qualcosa qui nel grande ambaradan dell’aneddotica rock. Ma forse il vero presagio – il segno in cui cogliere quello che sarebbe stato il futuro di Jeff Buckley – è il doppio album uscito lo stesso, con l’aggiunta di una parola onesta, un’avvertenza, quello Sketches for (e poi il titolo: My Sweetheart The Drunk). Senza una regia finale, nato dalla ridondanza dell’ispirazione e non da vene esaurite – vene d’oro su cui stava investendo oro vero la Columbia Records – presenta un caleidoscopio di suoni, canzoni vere e mezze canzoni, spunti e flash, che tirano da ogni lato, litigandosi musica e vita del Jeff Buckley prossimo venturo.
Negli Sketches i Nirvana cantano come Thom Yorke, gli Zeppelin e il prog – così snobbato ai tempi – si fondono o si giustappongono a una sorta di evoluta new wave che tiene vivo un cerino di furia punk. Tutte etichette prese da commenti sul web. Ascoltiamo e basta. Viene in mente, subito, la rivendicazione di Jeff Buckley, forse stremato dai tour continentali post Grace, anzi dai tour per vendere più copie di Grace nei Paesi che davano concrete risposte di acquisto: Buckley sogna di potersi ritrovare su un piccolo palco improvvisando di canzone in canzone il concerto che più sente e più lo diverte, in contatto col pubblico, certo, ma pronto pure, caso mai capitasse, ad annoiarlo e deluderlo. Non stava facendo forse questo a Memphis, attendendo di chiamare a sé – per finire il difficile e inafferrabile secondo album – la sua crew?
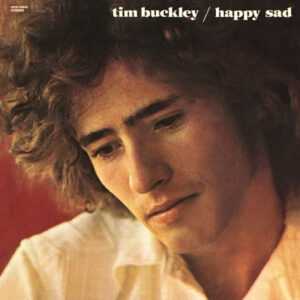
Ancora sui padri e i passi perduti
Entrambi sono prima di tutto due figli trascurati: Tim da un padre veterano della Seconda Guerra Mondiale, distante e spesso ubriaco. E Jeff, be’ Jeff vide Tim per una manciata di giorni, a Pasqua del 1975, poco prima che morisse per overdose, Jeff aveva 8 anni, Tim 28 – Jeff e Mary, la fidanzata dell’adolescenza lasciata quando Tim scelse di inseguire la gloria a New York, non vennero nemmeno invitati al funerale.
Dice Jeff in una intervista dell’agosto 1994 a Ted Kessler per The Guardian: “I knew him for nine days. I met him for the first time when I was eight years old over Easter and he died two months later. He left my mother when I was six months old. So I never really knew him at all. We were born with the same parts but when I sing it’s me”.
Precisa: “This is my own time and if people expect me to work the same things for them as he did, they’re going to be disappointed. Critics try to pin so many different inaccuracies on me and my music, they look at the complicated things and try to simplify them. They think they can nail your whole life down just by knowing the bare bones of your history in partaking in 10 minutes of conversation. If you’re going to write, then write a novel with a Haitian woman in it and try and describe her accurately. When you can do that, you can write about people”.
Viene spontaneo notare che Jeff Buckley oltre al danno di non aver avuto un padre, subisce pure la beffa di venir definito figlio d’arte, nel senso – molto doloroso – di essere etichettato come erede dell’arte di Tim Buckley, un’emanazione se non un imitatore, o peggio di tutto: un clone, senza meriti, per via del DNA.
Ovvio che questa discendenza genetica da Tim – lo sconosciuto – suoni pari a un insulto: all’angoscia reale provocata dal mancato rapporto col padre, si aggiunge la ben nota “anxiety of autorship” (Harold Bloom docet), la necessità di essere percepito come un artista “a parte”, valido di per sé, portatore di proprie parole e note. Non fosse per quella voce…
***
Da Hallelujah a The Last Goodbye di Dave Lory è il titolo della biografia dedicata a Jeff Buckley, uscita il 26 giugno per Il Castello marchio Chinaski Edizioni
Credit: “Jeff Buckley” by www.higbyphotography.com is licensed under CC BY-NC-SA 2.0





